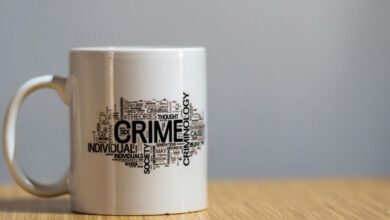Il Medio Oriente e noi: quanto il dramma della guerra ci invita al cambiamento?
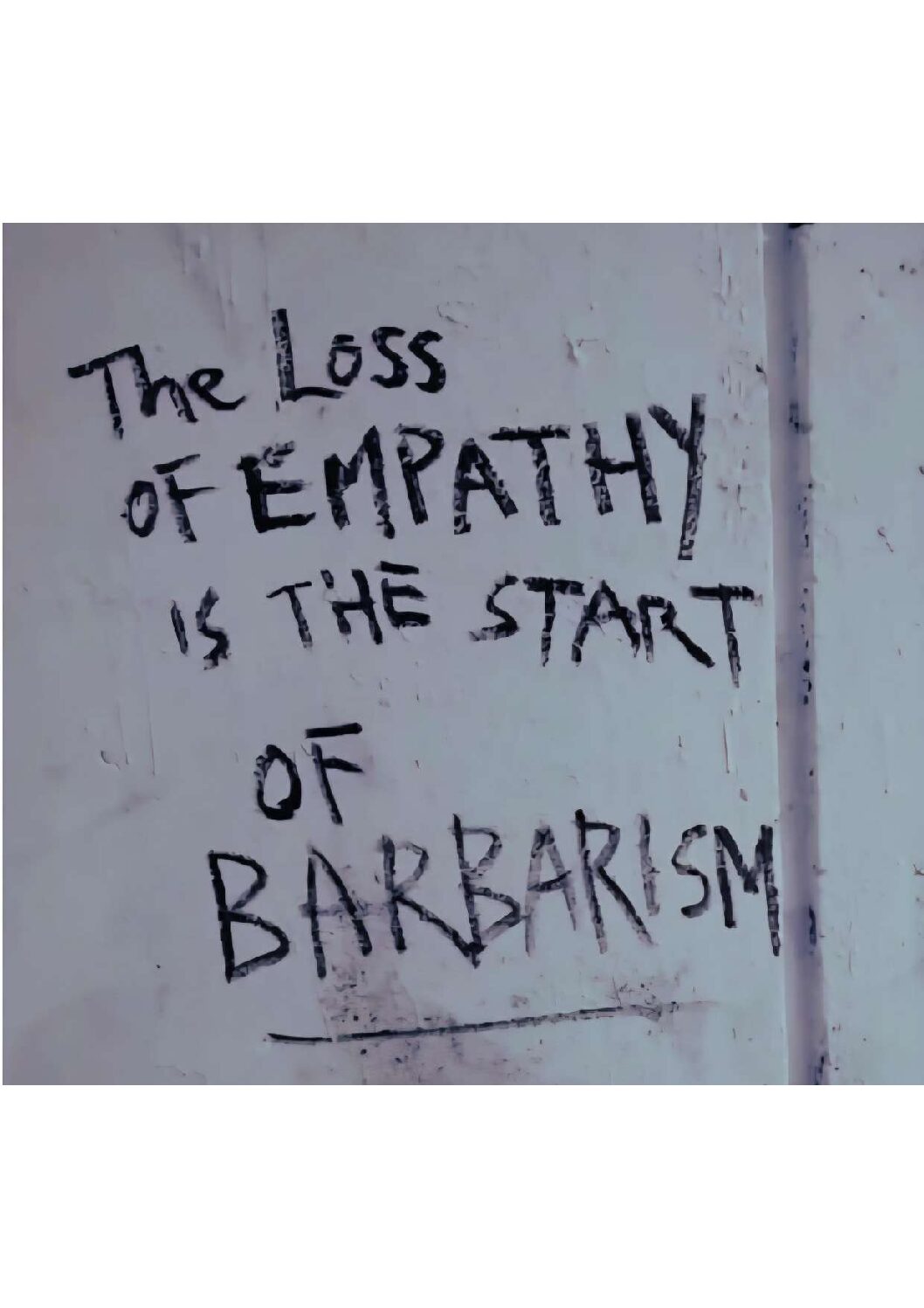
Quanto la decennale crisi mediorientale ci sta danneggiando nel profondo senza che riusciamo ad accorgercene? Quanto i suoi aggiornamenti e le quotidiane evoluzioni penetrano in profondità nel nostro io, stravolgendo le nostre certezze, i pensieri che credevamo inscalfibili e quella quasi forzata indifferenza che in troppi abbiamo avuto dinanzi ad ogni evento accaduto in quell’area, a partire da diversi decenni fa, per poi arrivare ai giorni nostri.
Sappiamo tutti che in Medio Oriente da troppo tempo il dolore prevale sulla gioia, che l’umanità li ha perso e l’opportunità di unire culture e popoli diversi sembra smarrita, comunque troppo debole per farsi strada nelle barriere imposte dall’estremismo religioso, dalle componenti politiche messianiche, dal terrorismo, dalla paura.
La paura. Paura. Paura. Paura. PAURA. Io che scrivo questo articolo ne cambio le forme, la modalità e grandezza di scrittura. Posso farvela leggere in maiuscolo o minuscolo, corsivo e grassetto, utilizzare un suo sinonimo, stravolgere il termine come credo ma la sua essenza e brutalità, quella, non posso mai cancellarla. La morale odierna della paura è che cambia forma ma comunque resta: potete sentirla o vederla, magari se andate in un posto silenzioso e chiudete gli occhi, anche voi. La paura ha sempre un senso opprimente al giorno d’oggi, ed è ogni istante più potente. È lei che ritorna e che accompagna, talvolta sembra quasi sparire ma in realtà non va mai totalmente via.
Non voglio sembrare intenzionato a leggere nella mente di voi lettori e sembrare saccente ma penso di poter affermare senza distanziarmi troppo dalla realtà che in questi tempi la paura è parte integrante anche di ognuno di voi. È capace di riaffermare la propria presenza inamovibile che ci accompagna esseri umani sin dalla venuta al mondo. L’abbiamo conosciuta tutti da bambini per la prima volta la paura, senza che sapessimo cosa fosse e manco darle un nome. Poi crescendo siamo riusciti spesso a tenerla a bada, a non arrenderci alla possibilità che prevalesse.
Oggi la paura sembra aver prevalso su tutti noi
Oggi riusciamo ancora a farlo? Quel che accade al di fuori del nostro caldo e confortevole guscio domestico quanto impatta sulla nostra persona e coscienza? Quanto tutto ciò che osserviamo è donatore di paura e trauma destinato a segnarci, sperando ci trasmetta almeno la forza di riflettere? Quanto attualmente la conformazione e ripetizione di immagini, rumori, siluri, pianti, urla, suoni e drammi che ci rapportano alle condizioni politiche, militari ed umanitarie del Medio Oriente assume un protagonismo drammatico e decisivo nel nostro confronto con la paura? Un bambino che abbraccia un pupazzo in preda alla disperazione circondato dal devasto, un suo coetaneo che dopo attimi dubbiosi accoglie una caramella in regalo, una famiglia che aspetta da oltre due anni le spoglie di un figlio sequestrato, reso ostaggio e poi ucciso, una casa, una città oppure un kibbutz andati distrutti in pochi minuti, quanto sono realmente distanti da noi? Possiamo permetterci di ignorarli e ritenerli estranei? Sono esempi di vita martoriata o strappata via da tenere impressi più di tatuaggio perché accaduti a qualcuno che è stato deciso solo da fato e fortuna non fossimo noi.
È per questo che certe scene ci opprimono e devastano, o addirittura trascinano nel baratro del caos e pesano come un macigno: fungono da leva per trasmettere all’anima, tramite gli occhi, un messaggio diretto: tutto questo ci appartiene e riguarda. C’è un istante che rimane lì piantato eternamente canta Ligabue nel ritornello della sua “Per sempre”: esistono voci, momenti e situazioni destinate a restare impresse per sempre nel nostro animo o nella memoria che custodiamo, e questo non avviene per caso. Oggi questo meccanismo, che spesso si ripropone correlato al trauma, è accompagnato dall’evolversi della cronaca che si ripropone ed alla fine prevale, si insedia con modalità e metodologie schiaccianti sul nostro individualismo interiorizzato e la malsana abitudine all’indifferenza che ha contraddistinto il percorso di maturazione caratteriale nella società occidentale.
La nostra società, più che un sogno, ha regalato un inganno:
La società che abitiamo ci ha ingannati: ha promesso la felicità al contempo illudendoci, fino a convincerci, che al di fuori del nostro cerchio ristretto non ci fossero più diritti, doveri, concetti di umanità e giustizia che dovessimo contribuire a salvaguardare. Il menefreghismo è andato a nozze con l’estremizzazione dell’individualismo, costruendo il più grande bluff che l’Occidente liberale abbia mai partorito: quello della serenità possibile in assenza di consapevolezza. Oggi le nostre coscienze, d’un tratto turbate e risvegliate, producono scossoni emotivi uniti ad un gelido bruciore che al tempo stesso ghiaccia ed ustiona l’anima, senza che al paradossale ed in apparenza avvenimento in controsenso si riesca a dare un nome o trovare rimedio.
Nel processo di consapevolezza, restiamo ingabbiati a causa catene della contrapposizione, dell’invalidazione dei pensieri altrui, della componente etica, religiosa e morale differente che può essere presente in un’altra figura e non ci è dato giudicarla, anche se all’apparenza presenta tratti per noi sconosciuti o non amabili. Riscoprirci umani per mano dei drammi che si osservano, pure all’apparenza lontani, è una preziosa opportunità che in dono l’amaro destino globale ci sta portando. È questo un procedimento figlio della catalizzazione della paura. Ci spaventa inizialmente qualcosa di cui comprendiamo l’entità (come il dramma della guerra e della sofferenza, soprattutto degli innocenti, che ci colpevolizza) ma che non riteniamo assimilabile con il nostro io o modo di essere.
Questo è il tranello che si verificato spesso in Medio Oriente nel corso della storia, anteponendo la logica del sopruso, dello scontro, della violenza e dell’incompatibilità con quella dell’umanità, del rispetto e della vera pace, duratura e giusta. E su un parallelismo possibile e non illogico, è quello che accade a noi che ci distanziamo emotivamente ed empaticamente, rifugiandoci nell’indifferenza o nella non comprensione delle piaghe profonde delle tragedie, provando ad addormentare la nostra coscienza che riteniamo violata.
La consapevolezza come principio per attivarsi e promuovere un cambiamento
Arrivare ad un livello di consapevolezza maggiore è forse il segnale di esser riusciti a catalizzare la paura ed averle dato una conformazione, lasciandole uno spazio su cui poter lavorare nel nostro percorso e processo di cambiamento, da promuovere al tempo stesso in una società che ha interiorizzato degli schemi sbagliati. È uno spaccato di vita nostra, di comunità assente ed educazione famigliare e sociale tramandatisi nei decenni completamente errata, quella che oggi ci pone dinanzi all’entità delle sfide globali privi degli strumenti umani capaci per reagire adeguatamente a ciò che di drammatico osserviamo.
Il Medio Oriente è maestro di quotidianità amara, periodi storici drammatici che si ripetono, esempio plastico di quanto il baratro possa rivelarsi profondo e – soprattutto – trascinare pure noi dentro se ottusamente proseguiamo con l’ignorare quanto esso ci sia vicino. La perdita dell’empatia è il principio della barbarie ho letto scritto su un muro, ed è qui forze che si innesta la chiave: l’indifferenza frutto di ciò che abbiamo interiorizzato e vissuto negli anni ha portato alla contrapposizione con quel che osserviamo spingendoci a mantenere da esso una distanza. Il parallelismo tra l’assenza di umanità che contraddistingue l’evolversi ed il ripresentarsi costante della guerra e la nostra abitudine al fatto che quella violenza si ripeta pedissequamente è ciò che fino ad oggi si è verificato, trovando però un ostacolo con il ritorno al protagonismo dell’emozione primaria della paura.
Quest’ultima ci ha trascinato nella fase di cambiamento ed evoluzione fungendo da spia emergenziale che avvisa di un pericolo per una condizione non più sostenibile. È la società nostra con l’esistenza nelle forme attuali che conduciamo al suo interno a non essere più tollerabile ed accettabile, destinata a crollare. La costruzione di qualcosa di nuovo, più umano e diverso spetta ad una collettività, non ad un insieme di individui come si credeva. Questo è la paura che proviamo che invita a comprenderlo. In effetti, a far spavento è pure che così in ritardo ce ne si stia accorgendo.
È forse qui il punto primario di consapevolezza da acquisire per poter contribuire a dar vita ad un cambiamento, insieme a tutte e tutti.
TOMMASO ALESSANDRO DE FILIPPO
Leggi Anche : La kefia, quel filo che intreccia storia, identità e moda