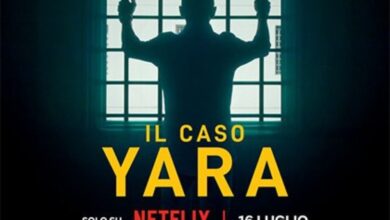Io non volevo vivere, volevo solo mangiare

Decido di saltare la staccionata oggi che mi sento brutta. È naturale sentirsi brutti tanto quanto sentirsi belli, affascinanti e intelligenti.
Oggi è una di quelle giornate che passerei volentieri a lamentarmi di cosa non mi piace, di quali piani organizzerei per essere felice, di cosa potrei imitare degli Altri e cosa invece non sarò mai di Loro.
Non c’è destinazione se non sai dove andare, non c’è partenza se non vuoi partire.
Allora puoi spegnere tutto, pensare alla cima, perché c’è sempre un modo, ma tu non lo sai ancora.
Chi vuoi che creda se tu non credi in te?
Ogni volta che cerco dei sintomi, Internet mi dice che sto per morire.
Così, ogni volta che sto male finisco in un vortice di link, forum e articoli medici che mi conducono negli abissi delle diagnosi più nere. Questa malata routine è da moltiplicarsi per tutti i giorni in cui il dolore e l’angoscia persistono, finché le mie esplorazioni superano il tempo che spreco per le stories su Instagram.
E so di non essere l’unica.
Non ho mai parlato a nessuno dei miei disturbi alimentari perché tutt’oggi credo di non averne, o forse, per la mia ansia è più comodo non preoccuparsi dell’idea di essere malata o di potermi ammalare.
Guardarsi allo specchio è facile, basta posizionarsi alla giusta distanza, ruotare le braccia, osservarsi minuziosamente e cercare di far fede a quell’immagine di noi sempre e per sempre. Io non ho mai avuto grandi problemi con il mio corpo, sì forse un po’ bassina ma con ogni cosa posizionata lì dove doveva stare.
Non credo che esista un manuale o una strategia per accettarsi: chi si vuole bene si guarda affettuosamente e con tolleranza. Né la mia vita è mai dipesa dai giudizi altrui, intrisi di standard irrealistici, contraddittori e di conseguenza deleteri per chiunque si senta meno bene di me.
Da piccola ho vissuto una strana infanzia, sentivo di temi assurdi per la mia età con argomentazioni fuori dal comune. In famiglia mi sono sempre sentita diversa, e mi piaceva ma ero grande a 10 anni, grande veramente. Ho sempre avuto ottimi risultati a scuola e per lo studio ho rinunciato a molte cose, accantonando sentimenti e svaghi. Fin quando negli ultimi anni di università è cominciato un periodo di instabilità psicologica con attacchi d’ansia, cambiamenti di umore repentini e una fame compulsiva, e forse da lì i miei mostri hanno preso il nome di disturbi.
Tre anni fa decido di mettermi a dieta, non perché ne avessi bisogno ma perché avevo voglia di cambiare delle cose di me che non mi piacevano, sentivo la necessità di seguire un certo rigore, certa che la determinazione mi avrebbe permesso tutto.
Dopo nove mesi ho perso 16 chili, arrivando a pesarne solo 51 che per me, corpo e peso nella norma, era veramente poco. Ho passato un’estate in balìa di occhiate vili e parole urlate di nascosto. In tutta onestà non mi piacevo, ma accettavo i complimenti di tutti con orgoglio e gioia.
Se da un lato la frase “stai molto bene così, adesso però basta!” mi permetteva di apprezzare e capire tutti i sacrifici e le tentazioni superate, dall’altro c’era la paura che da quello strano vizio di normalità malata non mi sarei più allontanata.
Ho cominciato a trovare problemi in ogni parte di me, dalle clavicole, alle gambe, alla pancia, al seno e anche alle caviglie. È vero avevo perso 16 chili eppure, non era tutto successo in maniera sana e consapevole.
Per un certo periodo di tempo alternavo momenti di digiuno in cui saltavo completamente i pasti e sopperivo la fame con qualche sigaretta in più, a periodi di binge eating incontrollati a cui seguivano, chiaramente, sensi di colpa irreversibili. Convinta di avere sempre, per ogni grammo di bilancia, tutto sotto controllo. Mi trovavo in quella fase chiamata “luna di miele” dove all’inizio il disturbo ti fa sentire bene e tutto intorno a te sembra perfetto.
Tutti si accorgevano della mia perdita di peso, a cui è susseguito un periodo abbastanza stabile. All’apparenza.
Non seguivo più alcuna dieta, avevo deciso non fosse più utile. Così cercavo di concentrarmi solo ed esclusivamente sul mantenimento di quel peso, ma con la costante ansia di ritornare lentamente a quello iniziale. Lo spettro del fallimento era sempre presente e sempre vicino, tant’è che per settimane, se ero fuori casa, mangiavo solo noci e mandorle. Per quanto mi piacesse quella condizione, in realtà desideravo solo mangiare, riempirmi fino a star male e poi finire la sera per sentirmi in colpa.
Il cibo era un’ossessione, insieme alla bilancia a cui mi sottoponevo anche per tre volte al giorno.
Dovevo continuamente fingere per evitare che attorno a me il mio stato d’animo fosse evidente, così ringraziavo per gli apprezzamenti, utilizzavo per lo più abiti larghi, e promettevo a tutti di star mangiando bene. Non capire la causa esatta che riusciva a spiegare questo comportamento assurdo mi portava alla disperazione, ma la paura di essere fuori da questo stesso comportamento distruttivo mi terrorizzava.
Quello che per me era realmente essenziale era restare coerente, senza oscillare mai. E invece tutto sembrava un’altalena, avevo dentro di me due parti, una che mi permetteva di desiderare qualcosa e l’altra, troppo severa, che annientava questo mio desiderio e prendeva sempre il sopravvento.
Desideravo non esistere più per dimostrare che esistevo, a patto che nessuno mi giudicasse.
Digiuni e abbuffate. Poi i sensi di colpa, ma mai il vomito autoindotto. Quello per me lo faceva chi era malato e io sapevo prepotentemente di non esserlo. Dopo tre anni, mi sono resa conto che il cibo nascondeva una miriade di cose e che ogni piccola cosa di quell’ansia mascherava un problema.
Sicuramente contare le calorie, far ruotare le mie giornate intorno al cibo e focalizzarmi sul grasso era un modo per non pensare ad altro e si sa, gli eccessi non sono mai auspicabili.
Questa costante volontà di inseguire le linee, non quelle curve né quelle spezzate che si interrompono e si ricongiungono, ma linee perfettamente simmetriche, altezze giuste e zone erogene più che attraenti, inevitabilmente mi spingono a rincorrere canoni che non mi appartengono, stereotipi e corpi che non ho mai condiviso, convincendomi che le mie linee sono troppo spezzate per potersi ricongiungere in una forma delineata e così perfettamente in ordine.
“Non esagerare, così metterai tutto quello che hai perso”, ma esattamente cos’è che ho perso?
Chili o paure?
Come sto oggi mi chiedo, negli infiniti dialoghi con la me di tre anni fa, e mi rispondo prendendomi in giro, beffandomi ancora di quelle debolezze che so nascondere bene.
Considerando che da bambina quando studiavo Dante, pensavo che sarei finita sicuramente nel girone dei golosi e che in diversi periodi della mia permanenza all’inferno avrei rimpianto ogni tipo di aiuto, sono felice di svegliarmi, mangiare e stare quasi bene.
Oggi indosso quello che voglio, a volte esitando.
Ho sempre il numero di una dottoressa salvato in rubrica, ma non ho mai chiamato.
Sono ancora schiava della bilancia, dei digiuni e dei sensi di colpa.
Ma non riempio più i vuoti con il cibo.
So benissimo che non vincerò. Nemmeno lo voglio, del resto.
Serena Palmese
Foto di Giovanni Allocca
Leggi anche: Tentativo di sopravvivenza numero uno