Politica e cittadini: non possiamo arrenderci alla disaffezione
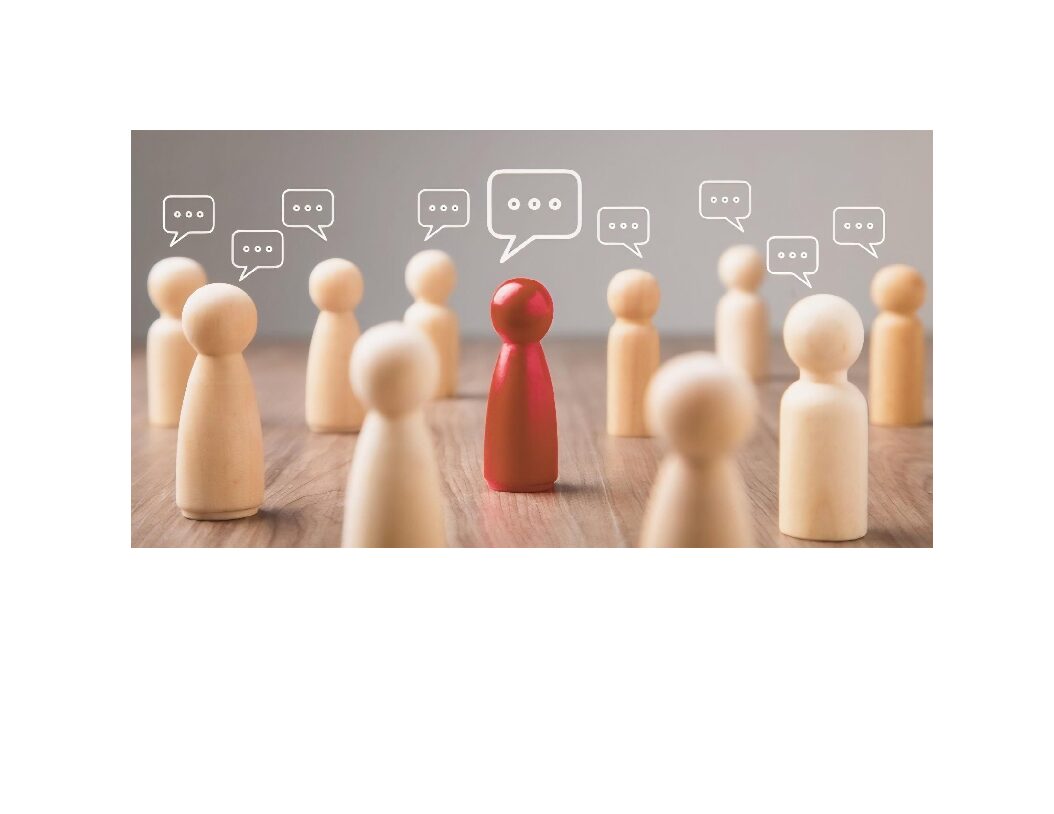
È una condizione drammatica per la salute di una democrazia quello in cui i cittadini – ed in particolare le nuove generazioni – si considerano irreversibilmente sfiduciate dalla politica, distanti dalla militanza attiva o anche solo dalla fiducia nelle istituzioni e l’espressione del voto.
In Italia c’è stata una resa sostanziale dinanzi a questo status quo, ragion per cui – al netto delle dichiarazioni retoriche sull’impegno per riacutizzare un legame sempre più allentato – è difficile riscontrare azioni che abbiano realmente intento e capacità di invertire la tendenza. Quella della distanza tra popolo e rappresentanti non è una problematica singola ed indipendente da altre che attanagliano la condizione dell’Italia: essa si intreccia con il deficit delle due velocità presenti nel nostro paese a seconda delle aree geografiche, alla disparità presente nella società civile, fino alle disuguaglianze di genere e territoriali tra Nord e Sud.
Tra le nuove generazioni i dati sono ancor più preoccupanti
Secondo dati ed analisi Istat con aggiornamento al 2024, i livelli più bassi di partecipazione politica riguardano i ragazzi fino a 24 anni e, in particolare, i giovanissimi: si informa di politica almeno una volta a settimana il 16,3% degli aventi tra 14 e 17 anni, come poco più di un terzo (34,6%) di chi ne ha tra 18 e 24. A non informarsi mai, invece, sono rispettivamente il 60,2% e il 35,4% degli appartenenti alle categorie anagrafiche. La disaffezione totale per l’informazione e la discussione politica aumenta anche a seconda del grado d’istruzione: non si informa mai di politica l’11,3% dei laureati, una percentuale più che doppia di diplomati (24,4%), e quasi quadrupla per quanti hanno al più la licenza media (41,2%). Un trend analogo si osserva in merito al semplice dibattere di politica.
Pesa, anche in questo scenario, la disparità tra Nord e Sud
La partecipazione è molto differenziata sul territorio: si informa sul tema almeno una volta a settimana la maggioranza della popolazione del Centro-nord (con valori compresi tra il 52 e il 54%), contro il 40% circa del Mezzogiorno. Sempre nelle regioni del Mezzogiorno una quota analoga (37,3%) non si informa mai a fronte del 25,0% circa delle regioni del Nord. In particolare Calabria, Sicilia e Campania presentano i livelli più bassi di partecipazione collocandosi ai primi posti per numero di uomini e donne che non si informano e non parlano mai di politica. Negli ultimi decenni, l’attenzione per la partecipazione nelle democrazie consolidate è aumentata a livello internazionale, sia in ambito politico che accademico. Gran parte di questo interesse nasce dalla preoccupazione per la diminuita affluenza elettorale e la crescente sfiducia nelle istituzioni della democrazia rappresentativa, oltre che nei partiti politici. Tra il 2003 e il 2024, si è osservato un calo generalizzato della partecipazione invisibile (informarsi e discutere di politica). Questo trend riguarda uomini e donne, ma con intensità diverse, contribuendo a ridurre le ampie differenze di genere.
Le differenze di genere restano un problema enorme
Nel 2003, ad informarsi con regolarità di politica era il 66,7% degli uomini a fronte del 48,2% delle donne. Nel 2024 questi valori calano di 12,6 punti percentuali per gli uomini e di 5,7 punti per le donne. La differenza tra uomini e donne passa da 18,5 a 11,6 punti percentuali. Nonostante la progressiva convergenza nelle forme di partecipazione politica invisibile di uomini e donne, permangono evidenti differenze di genere che vedono gli uomini partecipare più numerosi alla vita politica del Paese. Nel 2024, poco più di due donne su cinque (42,5%), infatti, si informa settimanalmente di politica, contro il 54,1% degli uomini. In particolare, è sull’informazione quotidiana che il gap di genere è più evidente (27,6% degli uomini e 19,0% delle donne).
Anche l’informazione affronta un cambiamento
Rispetto al 2003 l’uso della tv come fonte di informazione politica è diminuito di quasi 10 punti percentuali (dal 94 all’84,7%). Si è invece dimezzata, passando dal 50,3 al 25,4%, la quota di cittadini che si informano tramite i quotidiani: la maggiore intensità del calo tra gli uomini ha più che dimezzato il divario di genere nell’utilizzo di questo canale informativo: nel 2003 a farvi ricorso era il 56,4% degli uomini e il 43,3% delle donne, percentuali calate rispettivamente al 28,5% e al 22,1% nel 2024. Ad informarsi tramite Internet sono soprattutto gli adulti fino a 44 anni, tra i quali le percentuali superano il 60%.
Considerando nell’insieme i canali tradizionali e quelli accessibili tramite Internet, la radio e la tv restano i mezzi principali, utilizzati dall’89,5% della popolazione. Al secondo posto si collocano i quotidiani (cartacei oppure online): 41,7%, utilizzati dal 45,2% dei maschi e dal 38,0% delle donne. A seguire, senza particolari differenze di genere, le fonti informali (amici, parenti, conoscenti, ecc.), indicate da più di un terzo dei rispondenti, i social network, utilizzati da un cittadino su cinque, e le riviste (12,4%).
Degli oltre 15 milioni di cittadini di 14 anni e più che non si informano mai di politica, poco meno dei due terzi (63,0%) sono motivati dal disinteresse, più di un quinto (22,8%) dalla sfiducia nella politica stessa. Le differenze di genere sono minime: le donne indicano un po’ più degli uomini il disinteresse (64,3 contro 61,1%) e la constatazione che si tratti di un argomento comunque complesso (9,7% contro 7,5%), gli uomini più delle donne riferiscono di non aver tempo (8,1% a fronte del 6,5%). In 4 milioni 679mila famiglie, nessun componente ha parlato o si è informato di politica (17,6% delle famiglie residenti in Italia).
Complessivamente sono circa 7 milioni e mezzo le persone di 14 anni e più che vivono in famiglie con più componenti in cui nessuno parla di politica, poco più di 6 milioni vivono in famiglie in cui nessuno se ne informa. In circa un terzo delle famiglie calabresi e siciliane nessun componente di 14 anni e più si informa di politica a fronte di un valore medio del 20,9% e di valori che si aggirano intorno al 14% in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
Nel 2024, hanno partecipato ad un comizio o a un corteo rispettivamente il 2,5 e il 3,3% dei cittadini di 14 anni e più a fronte del 5,7 e del 6,8% del 2003. Il calo ha riguardato sia gli uomini che le donne, ma con intensità leggermente maggiore per i primi: nella partecipazione a cortei si è passati per gli uomini dall’8,2% al 3,1% e per le donne dal 5,6 al 3,4%. Ne è derivata anche in questo caso una riduzione del gap di genere e una convergenza nei comportamenti di uomini e donne.
Il problema della disaffezione politica è comunque…politico!
Il punto determinante è comunque – paradossalmente – politico: si assiste al tentativo di livellare verso il basso la percentuale di emergenza che alimenta le problematiche, ma non di risolvere le stesse. Inoltre, si predilige l’estensione a più fasce territoriali e sociali di un deficit – in una logica che sembra riattualizzare il celebre detto “mal comune mezzo gaudio” – sottovalutando le conseguenze che comporta la generale indifferenza della popolazione rispetto all’evoluzione della vita pubblica e dell’amministrazione politica nazionale.
Senza una collaborazione attiva tra chi esercita il potere decisionale (su mandato dei cittadini, sia pure della ridotta percentuale di coloro che si recano alle urne) e chi nella quotidianità contribuisce ad assicurare la sopravvivenza dello Stato con il proprio lavoro e l’esercizio di ogni funzione sociale, la promessa di cooperazione tra istituzioni e popolo alla base del processo democratico diviene vana.
Questo preclude il progresso comune e la possibilità stessa di creare una società maggiormente equa. Senza una componente istituzionale sarebbe impossibile pure l’autodeterminazione popolare, perché in assenza di vertici e decisori la gestione della cosa pubblica e della società diverrebbe impossibile. Al tempo stesso, se il quadro istituzionale e decisionale resta chiuso in una metaforica bolla, senza validare la spinta propulsiva, rispettare soprattutto riconoscersi nelle istanze popolari, la disaffezione civile andrà aumentando. In un paese già interessato da disparità, diseguaglianze e fenomeni emergenziali, la probabilità che le crisi sociali aumentino e diventino irreversibili – provocando anche temibili tensioni – dovrebbe preoccupare. Se chi riscontra problematiche strutturali per il proseguo della propria esistenza si sente invalidato, o percepisce una incompatibilità incolmabile con chi decide per la sua vita, ritenendo di essere pure ingannato, la prospettiva di caos diviene inarrestabile.
La chiave è nel rilancio di un patto sociale autentico
Quale chiave risolutiva può ritrovarsi per invertire la tendenza? Non ci si può arrendere alla disaffezione delle persone verso la politica ma, nello stesso frangente, è fondamentale che chi ricopra ruoli di vertice metta al centro le necessità di chi – nei fatti – ne ha garantito ascesa e permanenza al potere. Serve rilanciare un patto sociale che oltre a fornire risposte alle istanze popolari favorisca la ripresa di una relazione fiduciaria tra comunità civile e vertice decisionale, in un legame che favorisca una connessione paritaria ed orizzontale, priva di supponenza, retorica sterile ed inganni.
In alternativa, a finire ipotecato sarà il futuro stesso del nostro paese e non soltanto quello di singole categoria sociali o di apparato che ne fanno parte.
TOMMASO ALESSANDRO DE FILIPPO
Leggi anche : Zerocalcare: coerenza politica e impegno per la Palestina




