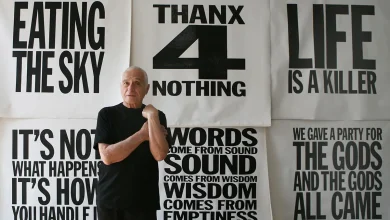Intelligenza Artificiale e creatività

C’è chi definisce l’Intelligenza Artificiale come una minaccia all’immaginazione umana, e chi, all’opposto, la considera la più grande rivoluzione dai tempi dell’invenzione della stampa a caratteri mobili. La sua applicazione ai campi creativi, quelli che tradizionalmente si ritenevano il massimo territorio d’espressione del genio umano, sta generando una trasformazione profonda, forse irreversibile, del nostro modo di produrre, consumare e interpretare la cultura.
Le nuove tecnologie offrono strumenti immediati e potenti per risolvere molte delle “difficoltà” che un creativo può incontrare nel proprio percorso, rendendo accessibili pratiche un tempo riservate a chi aveva competenze specifiche o anni di studio alle spalle. Per molti, questo rappresenta un’opportunità straordinaria: la creatività viene democratizzata, e chiunque può cimentarsi nella scrittura, nella musica, nel disegno o nella progettazione visiva senza barriere d’ingresso. Eppure, l’altra faccia della medaglia è evidente. Se chiunque può generare un testo e dichiararsi scrittore, o creare immagini e definirsi pittore, cosa accade al valore dell’originalità? Che ne è dello studio, della tecnica, della passione, dell’esperienza vissuta e sedimentata, che da sempre costituiscono il cuore dell’espressione artistica?
Il primo pericolo, e forse quello già più visibile, è l’overdose di contenuti standardizzati.
Gli stili tendono a ripetersi, a imitarsi e a moltiplicarsi all’infinito, privilegiando la quantità sulla qualità. I modelli di IA si nutrono di opere umane, spesso senza consenso né rispetto del diritto d’autore, e producono risultati “nuovi” solo in apparenza: in realtà sono combinazioni statistiche di elementi esistenti. Nel frattempo, interi settori professionali si trovano a dover affrontare un cambiamento repentino e destabilizzante: traduttori, illustratori, copywriter, grafici, musicisti. Molti vivono oggi tra precarietà e conversioni forzate, schiacciati da strumenti capaci di sostituirli almeno in parte, pur senza possedere alcuna coscienza o sensibilità. Se da un lato cresce la fascinazione per questo “miracolo tecnologico” che consente a chiunque di “realizzare” qualcosa in campo artistico, dall’altro serpeggia il timore di un impoverimento culturale, in cui anche la creatività rischia di essere ridotta a semplice algoritmo.
Qui emerge una riflessione inevitabile: sarà sempre l’essere umano a decidere come, quando e dove ricorrere all’uso dell’IA? La utilizzeremo come scorciatoia, o come strumento capace di ampliare i nostri orizzonti creativi?
Spotify e gli “artisti fantasma”
Un caso emblematico arriva dal mondo della musica in streaming. Negli ultimi anni, piattaforme come Spotify hanno visto un’esplosione di “artisti” generati con l’IA: profili di cantanti inesistenti, spesso sostenuti da importanti case discografiche o da produttori anonimi, capaci di accumulare milioni di ascolti. Il risultato è duplice: ogni click su un brano artificiale è un click in meno per un artista reale, con effetti economici tangibili e un impatto culturale profondo. Il rischio è quello di abituarci a un panorama sonoro omologato, costruito su calcoli matematici anziché su esperienze, emozioni e vissuti.
Nel 2024, tre colossi dell’industria musicale (Universal Music Group, Sony Music e Warner Music Group) hanno intentato cause contro le piattaforme Suno e Udio, accusandole di aver utilizzato brani protetti da copyright per addestrare i propri sistemi generativi. Secondo le etichette, queste IA sarebbero in grado di imitare lo stile e persino la voce di musicisti esistenti senza licenza né compenso. Una contesa che mette in gioco miliardi di dollari e, forse, il futuro stesso dell’industria musicale.
Il Caso Brainrot: quando l’assenza di tutela diventa business
Un caso recente ha reso ancora più evidente quanto l’assenza di tutela legale possa trasformarsi in un’opportunità commerciale per chi sa muoversi rapidamente. Parliamo del fenomeno Brainrot, una serie di immagini e personaggi generati interamente con l’IA, diffusi inizialmente sui social come semplice esercizio creativo.
Tutto ciò, pur essendo privo di un apporto umano sostanziale e quindi non tutelabile dal diritto d’autore, è diventato “terra di nessuno” sul piano giuridico. il vuoto normativo ha aperto la porta a una massiccia ondata di sfruttamento commerciale: diverse aziende, non necessariamente collegate all’autore originario del prompt. hanno iniziato a stampare i personaggi su carte collezionabili, t-shirt, poster, sticker, action figure e ogni tipo di gadget immaginabile, vendendoli liberamente sia online che in vari negozi fisici.
in assenza di diritto d’autore nessuno ha potuto rivendicare l’esclusività o bloccare queste iniziative, e l’universo visivo di Brainrot è diventato una sorta di brand diffuso, seppur privo di un proprietario legittimo. Il paradosso risiede nel fatto che l’opera, in virtù dell’assenza di copyright, ha potuto espandersi viralmente e generare profitti significativi, senza che l’ideatore originario potesse trarne beneficio economico nè rivendicarne ufficialmente la paternità. Qui si aprirebbe un’altra discussione: se le opere create con l’IA non possono essere “protette”, chiunque può appropriarsene e monetizzarle, con un effetto alquanto dirompente sull’intero mercato della creatività e del design.
La giustizia americana e l’arte senza autore
Nel 2023, Stephen Thaler, tra i pionieri della ricerca sull’IA, ha chiesto al United States Copyright Office di registrare come propria l’opera A Recent Entrance to Paradise, realizzata interamente da un suo algoritmo, la Creative Machine. La risposta del tribunale distrettuale di Washington D.C. fu netta: un’opera generata da una macchina, senza contributo umano sostanziale, non può essere protetta da copyright.
Nel 2025, la United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit ha confermato questo principio, ribadendo che il requisito della “human authorship” è imprescindibile: senza la firma di un individuo in carne e ossa, nessuna immagine, testo o brano musicale può essere riconosciuto come proprietà intellettuale. L’IA sta quindi mettendo in discussione la stessa definizione di autore. Da un lato, la legge rifiuta di riconoscere un software come artista; dall’altro, i creatori umani chiedono tutele contro macchine che sfruttano, o imitano, il loro talento. La giustizia americana, almeno per ora, sembra inviare un messaggio chiaro: la creatività, per essere riconosciuta, ha bisogno di un volto e di un genio umano.
Ma questo resta un terreno scivoloso e in continua evoluzione.
Le prossime sentenze e battaglie legali non stabiliranno solo chi potrà vantare diritti su un’opera, ma anche come verrà distribuita la ricchezza culturale ed economica in un ecosistema dove la frontiera tra umano e artificiale si fa sempre più sottile e incerta. Resta aperta la domanda finale, la più importante: l’IA è soltanto un pennello nelle mani dell’artista, o possiamo davvero arrivare a definire “artista” una macchina che risponde ad algoritmi?
Roberto Spanò
Leggi Anche: Mostre immersive: limiti e opportunità di un nuovo modo di vivere l’arte