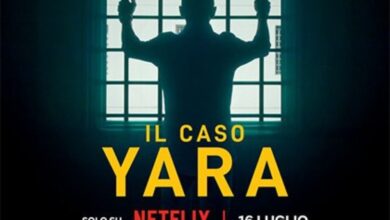Nove marzo duemilaventi: poesia e preghiera di Mariangela Gualtieri al pianeta

Nove marzo duemilaventi.
Il giorno in cui tutto è cambiato.
Il giorno della privazione, del chiuso, della recinzione.
Il giorno più buio.
Il giorno detto da Mariangela Gualtieri nella sua poesia, preghiera, canto.
Una lettera, un lamento di grazia, la voce di Mariangela Gualtieri legge la sua Nove marzo duemilaventi e sembra provenire da un punto imprecisato dell’etere, una voce antica di madre terra rivolta ai propri figli, inquieta e affettuosa, greve ma imperturbabile. Questa ninnananna della buonanotte, forse più un inno al risveglio, un richiamo alla presa di coscienza collettiva.
“Questo ti voglio dire
ci dovevamo fermare.
Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti
ch’era troppo furioso
il nostro fare. Stare dentro le cose.
Tutti fuori di noi.
Agitare ogni ora – farla fruttare.”
Agitare ogni ora. Ecco, esatto. Un invito alla lentezza, ad abbassare la prospettiva, immergendola nell’abisso del sé. L’evocazione in poetare dell’ossessione per il tempo, dell’idea di rendere ogni ora utile, importante, produttiva. Un’ossessione inutile, superficiale,volatile, occupata e preoccupata dell’esterno e non dell’interno. “Tutti fuori di noi”, dice la Gualtieri, riferendosi al nostro essere protesi, allungati, spiegati verso qualcosa d’altro, definiti con successo nel confronto. Ma tutto questo correre, uscire, dimostrare e dimostrarsi è una gara all’individualismo, all’affermazione del sé così radicata da non saper concepire l’idea della morte, del fallimento, del buio. La poesia cerca di recuperare questo senso di fallibilità umana senza renderla e trattarla come una labilità, un buco imperdonabile nella nostra evoluzione. Il senso è, invece, che
“ Ci dovevamo fermare
e non ci riuscivamo.
Rallentare la corsa.
Ma non ci riuscivamo.
Non c’era sforzo umano
che ci potesse bloccare.
E poiché questo
era desiderio tacito comune
come un inconscio volere –
forse la specie nostra ha ubbidito
slacciato le catene che tengono blindato
il nostro seme. Aperto
le fessure più segrete
e fatto entrare.
Forse per questo dopo c’è stato un salto
di specie – dal pipistrello a noi.
Qualcosa in noi ha voluto spalancare.
Forse, non so.
Adesso siamo a casa.”
Il grande abbraccio, avvolgente il pianeta intero, rivendica la necessità di abbassare le barriere, di fonderci con qualcosa di estraneo, potenzialmente letale, forse ci vuole rendere mostri, ibridi. Forse vuole che ci rendiamo vulnerabili, parti di un tutto che sembra sfuggirci.
È portentoso quello che succede.
E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano.
Forse ci sono doni.
Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo.
C’è un molto forte richiamo
della specie ora e come specie adesso
deve pensarsi ognuno. Un comune destino
ci tiene qui. Lo sapevamo. Ma non troppo bene.
O tutti quanti o nessuno.
È potente la terra. Viva per davvero.
Io la sento pensante d’un pensiero
che noi non conosciamo.
E quello che succede? Consideriamo
se non sia lei che muove.
Se la legge che tiene ben guidato
l’universo intero, se quanto accade mi chiedo
non sia piena espressione di quella legge
che governa anche noi – proprio come
ogni stella – ogni particella di cosmo.
Se la materia oscura fosse questo
tenersi insieme di tutto in un ardore
di vita, con la spazzina morte che viene
a equilibrare ogni specie.
Tenerla dentro la misura sua, al posto suo,
guidata. Non siamo noi
che abbiamo fatto il cielo.”
La parola, la proetina spike che si innesta nel DNA emotivo del lettore, riproduce l’animo sereno e fluido di questa divinità terrena, fattasi piccola donna per non destare una spaventosa meraviglia nell’uomo. Da portavoce del divino, il suono si innalza a lamento, a nenia guaritrice della terra tutta, delle sue falle e dei suoi doni. La “spazzina morte” non ha nulla di malvagio o di minaccioso, è solo un mezzo per riequilibrare le specie, permettendone il perdurare. Dobbiamo restare a casa, anche se non vogliamo.
“ Una voce imponente, senza parola
ci dice ora di stare a casa, come bambini
che l’hanno fatta grossa, senza sapere cosa,
e non avranno baci, non saranno abbracciati.
Ognuno dentro una frenata
che ci riporta indietro, forse nelle lentezze
delle antiche antenate, delle madri.
Guardare di più il cielo,
tingere d’ocra un morto. Fare per la prima volta
il pane. Guardare bene una faccia. Cantare
piano piano perché un bambino dorma. Per la prima volta
stringere con la mano un’altra mano
sentire forte l’intesa. Che siamo insieme.
Un organismo solo. Tutta la specie
la portiamo in noi. Dentro noi la salviamo.
A quella stretta
di un palmo col palmo di qualcuno
a quel semplice atto che ci è interdetto ora –
noi torneremo con una comprensione dilatata.
Saremo qui, più attenti credo. Più delicata
la nostra mano starà dentro il fare della vita.
Adesso lo sappiamo quanto è triste
stare lontani un metro.”
La grande divinità fa appello alla piccola divinità presente nel singolo, il dio interiore che permette la fusione dell’individuo con la specie, si affida all’altruismo, alla riscoperta di una coscienza globale che fonde uomo e uomo, uomo e terra, terra e cielo. Siamo insieme. Un organismo solo. E riabbracciarsi, sarà diverso, più forte, più lento, delicato. Sarà memoria del dolore della separazione, consapevole. Perché sì, adesso lo sappiamo, credo (ma non so) quanto è triste stare lontani un metro. Tenetevi stretti, saldamente, gli uni agli altri, aggrappatevi con tutte le forze. Manteniamoci.
Sveva Di Palma
Leggi anche Viaggio nella poesia di Mariangela Gualtieri