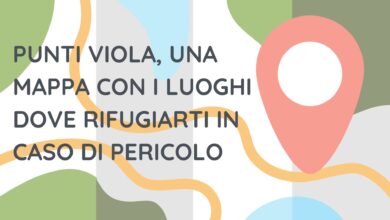Milano Fashion Week SS26 tra chi ha il coraggio di urlare e chi dorme beato nel privilegio dell’alta finanza

Una Milano Fashion Week spaccata in due. Da una parte i colossi che sbadigliano, ingessati dentro le solite formule che sanno di minestra riscaldata. Dall’altra una nuova generazione che irrompe, e ricorda che la moda non è un il servizio del telegiornale pieno di paroloni svuotati ma un linguaggio che può ancora graffiare, gridare e disturbare.
Il vero spettacolo sono le nuove proposte
Mentre i big si arrotolano goffi nei loro salotti dorati, quasi annoiati, l’aria nuova arriva da chi non ha paura di puzzare di collettivo, sudore e coraggio. Non i soliti abiti stirati “da prima fila”, pensati per non disturbare la bolla, ma progetti imperfetti che fanno dell’imperfezione la loro firma. Qui la moda non è heritage impolverato né finanza travestita da creatività è viva.
Marco Rambaldi tra crochet e bandiere che ci fanno piangere
Marco Rambaldi apre la sua SS26 Ready to Wear dimostrando che la memoria non è un soprammobile da spolverare a casa della nonna.
Il crochet, marchio di fabbrica, smette i panni del centrino da tavola e diventa tatuaggio cucito sulla pelle e sulle giacche multistrato, un ricamo domestico preso timidamente e rivisitato senza dimenticare che è di nonna. I cuori – che altrove finirebbero stampati sulle gonne di signorotte con villa e golf club – qui si nascondono come cicatrici segrete, come indizi di un cuore autentico sempre più raro da trovare negli umani. Poi gli anni ’50, non il solito richiamo con righe, fiori, réclame patinate da mogliettine felici e dive da cartolina di Capri. Rambaldi prende quell’immaginario borghese e lo ribalta, restituendo un femminile ironico e consapevole che invece di sorridere alla réclame mostra un dito medio elegante.
È una stoccata a un sistema che per decenni ha imposto uniformi severe e silenzi alle donne, trasformando lo sfruttamento in glamour. Rambaldi quell’archivio lo rende vivo, rispettoso e contemporaneo. Perfino gli accessori sono megafono. Borse in paglia e legno firmate Rosantica.
Troppo “basic” per un aperitivo radical-chic, ma qui l’onestà vince sull’esotismo da cartolina. E poi il finale, più forte di ogni comunicato: Rambaldi esce con la bandiera palestinese. Niente inchini zuccherosi, niente teatrini per le prime file, piuttosto un gesto timido ma potente che pesa più di mille discorsi, soprattutto accanto a chi la voce ce l’ha, ma non la usa per non turbare gli equilibri.
Simon Cracker e la sua gentilezza feroce nel tunnel della nostra testa
Poi c’è Simon Cracker (Simone Botte) con la sua SS26 “PUNKINDNESS FOREVER”. La location è già dichiarazione: il Major Virtual Tunnel, piazza De Angeli. Non un salone d’epoca né un cortile nobile, ma un tunnel rigenerato, un passaggio dimenticato che diventa crepa nel sistema.
Qui non sfilano modelle da cartellone, ma corpi non stereotipati con divise scolastiche strappate, bottoni da cento lire, e i famosi gatti Salem dipinti a mano, oltre che giacche gonfiate fino a scoppiare. È un patchwork anarchico che racconta più della realtà quotidiana di qualsiasi sfilata glamour con cartoline pompeiane e sensualità scintillante ferma agli anni ’90. Cracker non teorizza, mette in pratica. Mentre i big rimescolano l’“ugly” rendendolo chic da boutique o si perdono nelle solite supercazzole intellettuali, qui la moda torna sporcata ed è terribilmente viva.
Lorenzo Seghezzi, i riti nei corpi queer
Infine Lorenzo Seghezzi con la sua SS26 “Epitelio”. L’epitelio è la pelle che separa e connette, come barriera e passaggio: da qui la sua visione. Abiti che stringono e liberano, corsetteria che non costringe ma restituisce potere, ogni pezzo cucito a mano da loro, un piccolo atelier che sa di bottega più che di catena di montaggio (magari da terzisti)
La passerella è un rito queer: modelli e modelle genderless, corpi che rifiutano le etichette e si trasformano sotto gli occhi del pubblico. Non è inclusività da slogan, quì i corpi sono la collezione, non manichini che la indossano. Seghezzi parla con lente queer e artigianale. Rifiuta taglie standard, fonde maschile e femminile solo per demolirli, costruendo un immaginario dove la moda non rassicura, ma vibra, graffia e si trasforma.
In mezzo a tutto questo, Milano conserva due presidi fondamentali: la Fondazione Sozzani e Sara Maino. Loro che hanno compreso l’ovvio: senza emergenti, senza ricerca, la moda non esiste.
E poi arriva Sunnei, che ha deciso di non giocare più a nascondino: la moda oggi è finanza, punto. La loro SS26 non è stata una sfilata, ma una finta asta con tanto di telefoni e offerte, organizzata con Christie’s. Al posto delle modelle, due casse misteriose “in vendita”, una per il brand e una per i designer. Un teatro spietato, quasi brutale che, invece di edulcorare il sistema, lo ha sbattuto in faccia al pubblico. Altro che storytelling zuccheroso o slogan inclusivi da postare su Instagram o nelle scuole di moda, qui il lessico è autentico, ed è quello dei bilanci. La frase che resta impressa — “Fashion is finance, creativity is for sale” — pesa più di mille proclami rivoluzionari. Loris Messina e Simone Rizzo annunciano la loro uscita dal marchio. Non un addio alla creatività, ma un arrivederci che suona come liberazione, la conferma che certe verità non si possono più camuffare.
Se i colossi continuano a pavoneggiarsi tra “heritage” e cartoline nostalgiche, fingendo di navigare in mari ispirazionali, Sunnei ha scelto il gesto forse più politico possibile, quello di togliere la poesia e mostrare il meccanismo nudo e crudo. In un settore che campa di slogan abusati, parole ripetute alla nausea come “legacy”, “artigianalità” e “DNA” ricordare che dietro ogni passerella ci sono azionisti, margini e profitti è una provocazione che brucia. Non è la resa della creatività, ma la sua diagnosi più feroce, oggi la moda è soprattutto mercato, e il compito di chi fa ricerca è decidere se adeguarsi vestendosi di ipocrisia e inclusività performativa o resistere con coraggio e sincerità.
Milano, 29 Settembre 2025 (No non siamo a Milano ma fa scena)
Una Fashion Week che non si limita a sfilare, ci impone di riflettere.
Da una parte i big in pigiama griffato da 5.000 euro che applaudono sé stessi, dall’altra Rambaldi, Cracker, Seghezzi e Sunnei che disturbano gli equilibri. Non hanno budget stellari né prime file imbalsamate, ma hanno quello che i colossi hanno smarrito: il coraggio. E allora in questa città che ama chiamarsi capitale della moda, il vero lusso non è l’artigianalità da vetrina, ma il rischio, l’imperfezione, la carne viva che ancora ha il coraggio di gridare, senza mettersi in saldo nei giochetti della finanza.
E mentre salutiamo con rispetto e un po’ di nostalgia Re/Zio Giorgio — perché in fondo Armani è Armani, e possiamo dirlo a gran voce — resta una domanda che brucia: un giovane Giorgio Armani, oggi, da che parte si sarebbe schierato?
Serena Parascandolo
Leggi Anche: I brand africani che stanno ridefinendo la moda globale oltre i confini