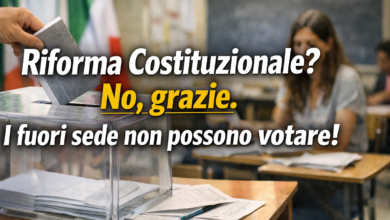È più vicina la povertà che la ricchezza: un italiano su quattro è a rischio
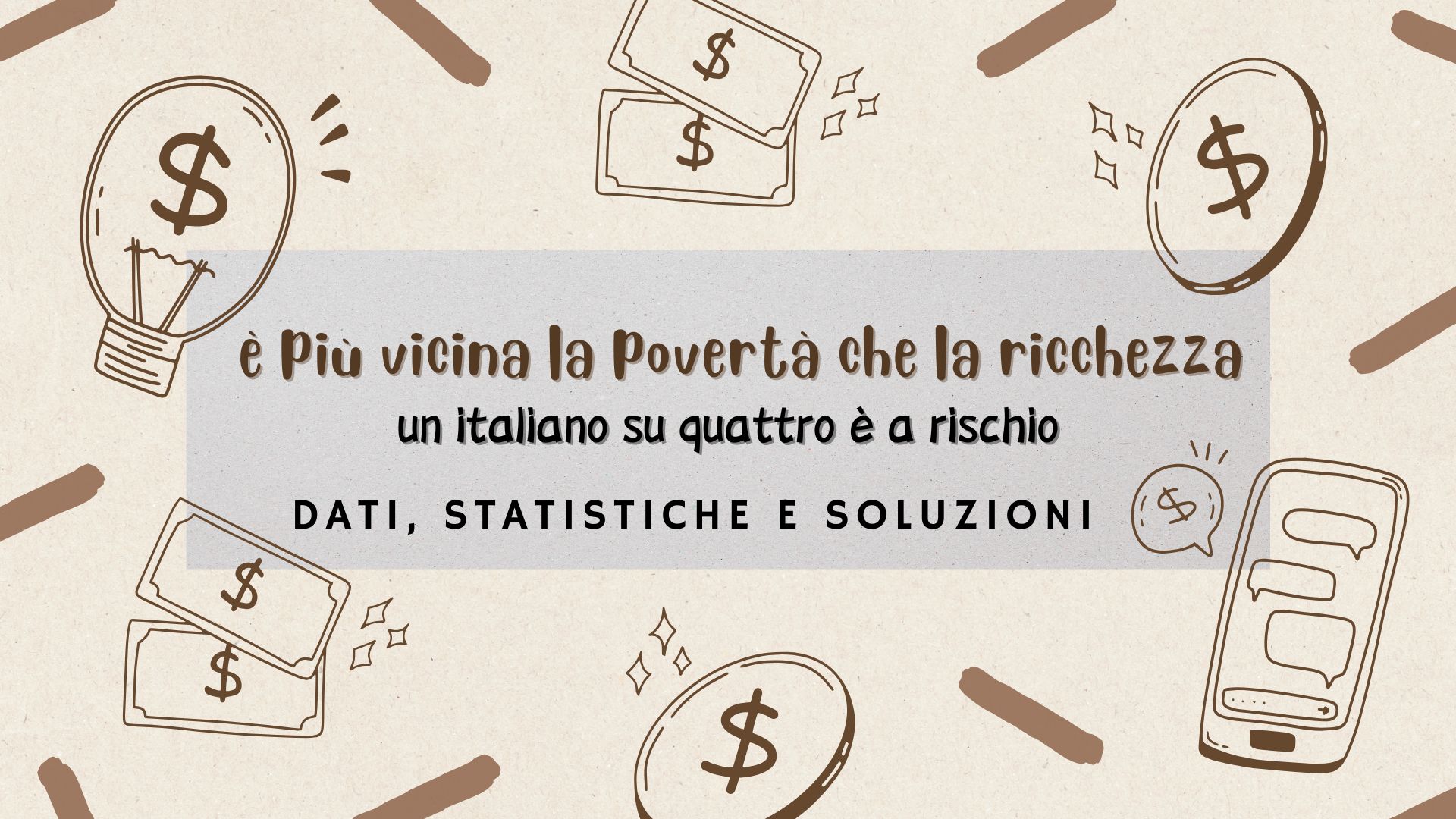
Il Forum Ambrosetti – Cernobbio del 2025, l’incontro internazionale su temi economici e politici che si riunisce ogni anno dal 1975, ci mostra dei dati allarmanti.
Le statistiche
L’Italia è tra i paesi dell’Unione Europea con la percentuale più alta di persone tra i 25 e i 49 anni a rischio di povertà o esclusione sociale. A peggiorare la situazione vi è un divario territoriale non indifferente, per cui le regioni del Sud Italia si trovano in condizioni socioeconomiche peggiori.
Anche i dati NEET (Not in Education, Employment or Training) sono fonte di preoccupazione. In Italia i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano sono 1,4 milioni, con un tasso del 15,2% contro una media europea dell’11%. Allo Stato costano 24,5 miliardi di euro, cioè l’1,23% del Pil.
Il campo dell’istruzione non funziona come dovrebbe e lascia l’Italia indietro rispetto all’Europa: tra fondi che mancano (e tagli ingiusti) e percorsi lunghissimi per diventare docente, gli adulti italiani sono i meno istruiti nella UE: nelle fasce di età 25-64 anni uno su tre ha al massimo la licenza della secondaria inferiore.
Tra le persone di 25-34 anni solo il 31,6 ha una laurea, a fronte del 44,5% della media europea. Anche tra bambini e adolescenti lo sviluppo delle competenze cognitive è nettamente inferiore rispetto alla media OCSE così come misurate dal sistema PISA, con i tassi di abbandono precoce degli studi più alti.
I possibili motivi
La povertà educativa e il rischio di povertà economica sono conseguenze di dinamiche multifattoriali. Spesso mancano risorse e opportunità di sviluppo negli anni formativi, e ciò porta molti giovani ad arrendersi alle proprie circostanze. La solita frase “volere è potere” proviene sempre da persone che si trovano in una posizione privilegiata, che non hanno mai avuto specifiche difficoltà economiche, e credono che basti volere qualcosa per realizzarla. Purtroppo, è tutto molto più complicato di così.
Bisogna tenere in considerazione le condizioni della famiglia in cui si nasce, i traumi generazionali e la sfera emotivo-psicologica, casi di disabilità che non ricevono l’appropriato supporto, tagli all’istruzione e alla cultura, la fortuna geografica e tantissime altre dinamiche su cui l’individuo spesso non ha alcun controllo, e può solo tentare di trarre il meglio dalle circostanze che gli sono state imposte, specialmente quando dallo Stato non arrivano aiuti.
Da un articolo di Blitz:
“La povertà educativa produce effetti diretti anche sull’economia: ostacola la creazione di oltre 3 milioni di posti di lavoro e accentua lo skill mismatch, con un deficit di 2,2 milioni di lavoratori qualificati. Sul fronte digitale, solo il 56% dei giovani possiede competenze di base, contro una media Ue del 73%. Secondo Teha, colmare questi divari potrebbe generare fino a 48 miliardi di Pil aggiuntivo e ridurre di circa 2 milioni le persone a rischio esclusione”.
Le possibili soluzioni
Alessandro Rosina, demografo e docente all’Università Cattolica di Milano, ha affermato:
“Gli altri Paesi europei sanno combinare meglio studio e lavoro attraverso percorsi tecnico-professionali più forti e sistemi di apprendistato efficaci. In Italia questi percorsi sono più deboli e concentrati al Nord, e un numero maggiore di giovani abbandona gli studi precocemente o arriva al diploma con competenze insufficienti. Anche i centri per l’impiego – quei servizi che dovrebbero accompagnare i giovani nel mondo del lavoro – sono carenti”.
E ancora:
“Le aziende italiane oggi investono meno in ricerca e innovazione; quindi, ci sono meno settori dinamici in cui i giovani possono esprimere le proprie competenze. Le aziende offrono stipendi più bassi e minori possibilità di crescita. Infine, ci sono due aspetti tipicamente italiani: il lavoro nero permette di sopravvivere nella condizione di Neet senza migliorare, e la cultura familiare consente ai giovani di rimanere dipendenti dai genitori fino a 30 anni, mentre negli altri Paesi europei all’età dei Neet – tra i 15 e i 29 anni – spesso si è già autonomi”.
Alla domanda sulle possibili soluzioni per migliorare la situazione economico-sociale italiana, Rosina ha risposto:
“Un giovane Neet va verso sfiducia e demotivazione, diventa un costo per la famiglia e poi per lo Stato quando la condizione si cronicizza. Non parliamo solo di ventenni, ma di trentenni senza lavoro né reddito. Dall’altro c’è il mancato guadagno per il sistema economico nazionale: in un Paese che invecchia e ha già pochi giovani, se non li mettiamo in condizione di essere attivi l’economia fatica a crescere. È il mancato contributo all’economia e allo sviluppo che quei giovani avrebbero potuto dare.
[…]
Dobbiamo invertire la spirale negativa. Anziché giovani che non studiano e non lavorano, serve un circuito virtuoso di studio e lavoro. La scuola deve rafforzare i percorsi tecnico-professionali e gli Its su tutto il territorio creando alleanze tra istituzioni, aziende e centri per l’impiego. I centri per l’impiego vanno potenziati per accompagnare i giovani, aiutarli a riqualificarsi e collegare domanda e offerta di lavoro. Serve investire in ricerca e innovazione per creare settori dinamici dove i giovani possano fare la differenza, aiutando anche le piccole e medie aziende a rinnovarsi. Ma soprattutto bisogna migliorare le condizioni salariali. Se un giovane pensa che dopo anni di studio troverà solo lavoro precario e sottopagato, preferisce non studiare o andarsene all’estero”.
L’Italia potrebbe sicuramente emulare alcune dinamiche economiche europee; ridurre il lavoro a nero, salari in parallelo con il costo della vita, opportunità sia lavorative che accademiche per i giovani e progetti di recupero sociale per le categorie più disagiate.
Intanto, chi gode di uno stato privilegiato (che sia per fortuna o per fatica), non dovrebbe mai darlo per scontato e aiutare chi si trova in condizioni peggiori, quando vi sono gli strumenti per farlo.
Siamo solo persone comuni e spesso, guardandoci intorno, è naturale sentirci sfiduciati e scoraggiati. Ma dobbiamo ricordarci che anche nel nostro piccolo il cambiamento è possibile: dobbiamo sempre aiutare quando ne abbiamo la possibilità, anche offrire supporto ad una sola persona può fare la differenza.
Immaginate. Cambiare la vita di una persona. Non è mica poco.
Marcella Cacciapuoti