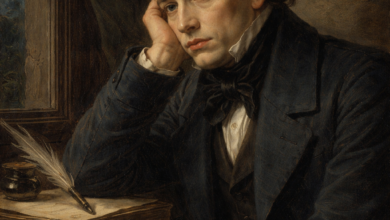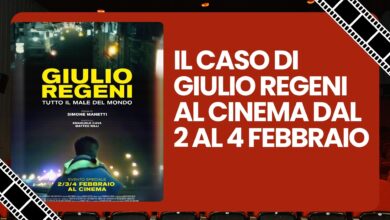C’era una volta in America: i segreti mai raccontati di un capolavoro controverso

Ogni 1° giugno ricorre l’anniversario di un film che ha segnato un’epoca.
È appena finito. Lo schermo si è spento, ma la sensazione è che qualcosa sia ancora qui, a fluttuare nell’aria della stanza.
Ho rivisto C’era una volta in America e, come ogni volta, un pugno nello stomaco, un viaggio che mi lascia svuotata eppure stranamente più ricca.
Non è solo un film, è un’esperienza, un labirinto di memorie, sogni infranti e tradimenti, e ogni volta che lo guardo, curiosa quale sono, scopro un dettaglio nuovo, una sfumatura diversa in un volto o in uno sguardo.
E proprio ora, con le immagini di Noodles e Max ancora impresse nella mente, mia mente complicata, mi sono resa conto di quanto quest’opera di Sergio Leone sia un pozzo senza fondo di storie, di retroscena che raramente vengono alla luce.
Una pellicola che più di altre ha incarnato l’epica del sogno americano e la sua ineluttabile caduta. È lei, C’era una volta in America di Sergio Leone.
Celebrato, frainteso, questo kolossal ha una storia produttiva e interpretativa talmente travagliata da nascondere un universo di segreti che, a distanza di decenni, continuano a sorprendere.
Dimenticate qui e ora le facili analisi e le leggende metropolitane e immergetevi, dopo di me, nei meandri meno esplorati di un’opera immortale.
Il taglio americano. Un crimine cinematografico voluto da… Nessuno? È risaputo che la versione distribuita negli Stati Uniti fu brutalmente tagliata da 229 a 139 minuti, stravolgendo la narrazione non lineare e la sua poetica malinconica.
E, pochi sanno che la responsabilità di questo scempio non fu di un singolo “cattivo” produttore. La Warner Bros., terrorizzata dalla durata e dalla complessità, incaricò un montatore, ma il vero dramma fu una combinazione di panico, pressioni del distributore e una fiducia malriposta in un pubblico americano ritenuto incapace di apprezzare una struttura così sofisticata.
Addirittura, Leone stesso, nel tentativo di salvare il salvabile, propose un finale alternativo per la versione americana che non fu mai usato, segno della disperazione di un artista di fronte alla mutilazione della sua opera.
Si dice che la Warner Bros. avesse persino accarezzato l’idea di un’uscita in due parti, prima di optare per la scure.
Il Romanzo da cui tutto ebbe inizio. The Hoods e il Lato Oscuro dell’Ispirazione.
Il film è basato sul romanzo The Hoods (in Italia “Mano armata”) di Harry Grey, pseudonimo di David Aaronson.
Ma ciò che pochi sanno è quanto la genesi del libro fosse legata alla vita reale. Grey, ex-gangster, scrisse il libro mentre era in prigione, un modo per dare un senso alla sua vita criminale.
Leone scoprì il romanzo per caso e ne rimase folgorato dalla disillusione e dalla memoria. La sfida fu tradurre in immagini una narrazione così intima e introspettiva, superando i limiti del genere gangster per elevare il racconto a parabola esistenziale.
La scrittura del libro fu per Grey una vera e propria catarsi, e Leone percepì questa profondità ben oltre la semplice cronaca criminale.
Le Audizioni Segrete e i Quasi-Noodles. Pensate che Robert De Niro fosse la prima scelta per Noodles? Non esattamente. Per anni, Sergio Leone aveva in mente di scritturare Richard Dreyfuss per il ruolo di Noodles. Tuttavia, dopo aver visto Toro Scatenato, Leone si convinse che De Niro avesse la fisicità e l’intensità necessarie per un ruolo così complesso.
E per Deborah? Per un periodo, il ruolo fu pensato per Brooke Shields, all’epoca giovanissima. Fu Jennifer Connelly, al suo debutto cinematografico, a dare il volto alla versione bambina di Deborah, con una performance che lasciò tutti a bocca aperta per la sua precocità e intensità. Il processo di casting fu lunghissimo e tormentato, con Leone che cercava volti “veri”, non solo attori famosi.
La Musica di Morricone. Un viaggio anestetico e la flauto di Pan. La colonna sonora di Ennio Morricone è leggendaria, ma pochi sanno quanto fosse intrinseca alla genesi stessa del film.
Morricone compose gran parte della musica prima delle riprese, un metodo insolito che permise a Leone di utilizzarla sul set per guidare il ritmo e l’emozione degli attori.
Addirittura, in alcune scene, la musica veniva suonata direttamente per permettere agli attori di immergersi nell’atmosfera voluta da Leone.
Un dettaglio meno noto è l’uso del flauto di Pan, un richiamo alla purezza infantile e al tempo perduto, che aggiunge un’ulteriore dimensione di nostalgia e malinconia al tema di Deborah.
Morricone stesso definì questa colonna sonora come una delle più difficili e appaganti della sua carriera, un vero e proprio “viaggio anestetico” nella memoria di Noodles.
L’Interpretazione Finale. Il Sogno Oppio o la Realtà Dimenticata? Il finale di C’era una volta in America resta uno dei più dibattuti nella storia del cinema: Noodles che sorride mentre l’effetto dell’oppio si esaurisce.
Ma è davvero solo l’effetto di una droga? Molti critici sostengono che l’intero film, o almeno gran parte di esso, sia un’allucinazione di Noodles, un tentativo di ricostruire e idealizzare un passato traumatico.
Ma una lettura meno comune suggerisce che l’oppio non sia tanto una fuga quanto un catalizzatore per un “ricordo puro”, un modo per Noodles di affrontare, e forse accettare, la sua realtà e le sue scelte.
È un sorriso di accettazione, di liberazione o di pura follia? Leone amava lasciare i suoi finali aperti, invitando lo spettatore a una profonda riflessione sulla natura della memoria, del rimpianto e del tempo.
Alcuni teorici, basandosi su frammenti di interviste a Leone, suggeriscono che il sorriso finale sia una sorta di “scherzo metafisico” del regista, che ribalta le aspettative dello spettatore sul destino tragico del suo personaggio.
I dettagli nascosti. Quanto mi piacciono. La continuità nascosta e gli oggetti simbolo. Leone era un maniaco dei dettagli. Ci sono innumerevoli richiami visivi che sfuggono a una prima visione.
Ad esempio, la valigia piena di denaro è un simbolo ricorrente, ma la sua forma e il modo in cui viene trasportata cambiano sottilmente a seconda del decennio, riflettendo il deterioramento dei sogni di Noodles.
Oppure, la ricorrenza del suono di un orologio, che scandisce il tempo che fugge e la disillusione. La cabina telefonica che appare in diverse epoche, quasi un portale tra passato e presente. Questi non sono semplici errori di continuità, ma scelte deliberate di Leone per rafforzare il tema della memoria e della sua inaffidabilità.
La sceneggiatura, lunga e complessa, prevedeva un numero di flashback e flashforward ancora maggiore, alcuni dei quali furono poi tagliati per ragioni di durata, ma i cui “fantasmi” persistono in piccoli indizi visivi.
E allora, C’era una volta in America non è solo un gangster movie; è un’ode alla memoria, un lamento sul tempo perduto, un viaggio nell’anima di un uomo.
I suoi segreti, le sue ferite e le sue infinite interpretazioni lo rendono un’opera viva, capace di parlare a ogni generazione.
Rivediamolo. Non solo per ammirare un capolavoro, ma per scavare più a fondo, per scoprire le sue cicatrici e le sue gemme nascoste, e per capire quanto il cinema, nelle mani di un maestro come Sergio Leone, possa essere un riflesso complesso e stratificato della vita stessa.
Lo rivedo con G.? Lo rivedo con G.
Francesca Scotto di Carlo
Vedi anche: Spaghetti alla Sergio Leone