La violenza che indossiamo
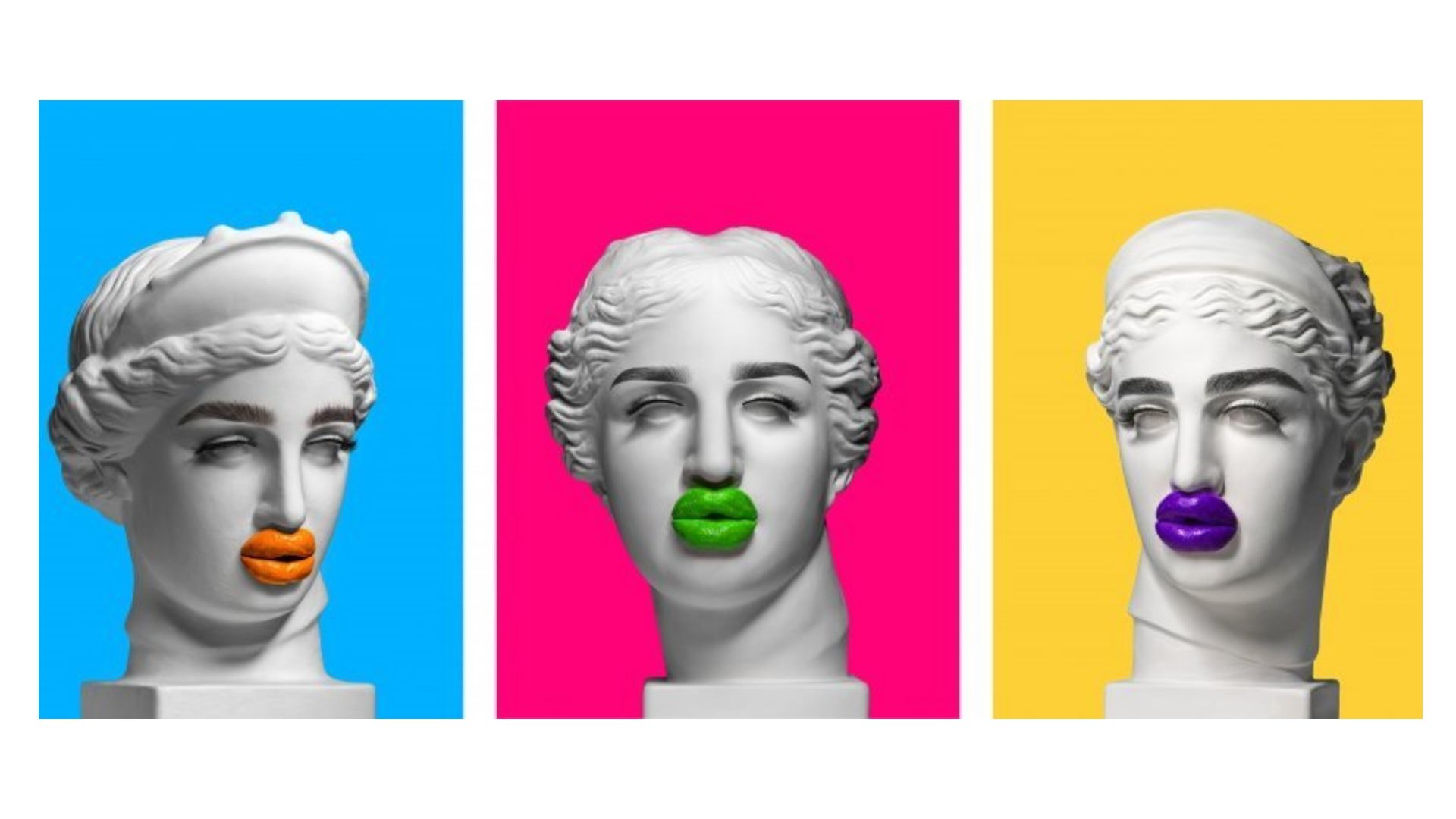
Prima di tutto c’è la narrazione. La violenza di genere inizia quando un sistema decide quali corpi possono parlare e quali devono restare zitti, la moda è uno dei segmenti in cui questa scrittura avviene ogni giorno.
Quando parliamo di violenza di genere, la mente corre subito alle scene peggiori, il corpo a terra, il sangue, la cronaca nera. È automatico, perché abbiamo imparato a riconoscere solo l’esplosione finale, mai la miccia. Ma ogni violenza ha un prequel che non fa notizia, un antefatto di parole, immagini, battute, silenzi e ruoli normalizzati come inevitabili. È lì che la violenza prende forma, molto prima dell’atto finale.
La moda in questo scenario ha una responsabilità enorme, non solo veste i corpi, li racconta. E chi racconta finisce inevitabilmente per costruire gerarchie nel bene o nel male. Ogni campagna come ogni passerella stabiliscono di fatto chi merita di esistere nello sguardo pubblico e chi deve dietro o – peggio ancora – fuori. La violenza di genere passa prima anche da qui, dal modo in cui un settore intero decide quali corpi valgono e quali devono tacere o sparire.
La moda non vende abiti, vende veri e propri copioni, fatti di posture, gesti e persino emozioni previste. La donna nella moda deve essere forte ma non troppo, indipendente ma mai minacciosa, sexy ma ironica, ribelle ma senza disturbare. Ogni narrativa costruisce parametri: questo sì, questo no. Questa storia è “ispirazionale”, questa è “troppo”.
Prima si delimita il corpo tra misure, linee, età, colori. Poi si impone un linguaggio fatto di difetti, imperfezioni, inestetismi se necessario. Intere generazioni trasformate in cantieri aperti, mai pronte, mai abbastanza, mai giuste. Infine si stabilisce chi può parlare, quasi mai chi vive nel corpo rappresentato. A farlo sono i vertici, uno sguardo esterno che decide che cosa vale e che cosa no. Ed è qui che il discorso sull’inclusività mostra la sua trappola. La parola “diversità” è ovunque, ma la regia resta identica. Il corpo non bianco, il corpo grasso, il corpo trans vengono accolti solo se funzionali allo storytelling della stagione, non come diritti ma come delle eccezioni controllate. Il messaggio non detto resta: ti riconosco, ma solo se resti al posto che ho deciso io.
Con lo spazio funziona uguale. Nelle immagini di moda i corpi femminili sono quasi sempre immobili, decorativi, fotografati come oggetti estetici. A muovere la scena è chi sta dietro la camera, non chi la occupa. Ed è sempre lo stesso sguardo – maschile, bianco, occidentale, anche quando non lo è anagraficamente, è un modo di vedere il mondo, non una persona.
Ma c’è un piano che raccontiamo ancora meno, quello materiale.
La moda ha un volto femminile, ma anche una base femminile. Più dell’80% delle persone impiegate nella produzione globale di abbigliamento sono donne. Si stima che 75 milioni di lavoratori alimentano il sistema moda e che il 98% non percepisca un salario dignitoso.
È pura violenza economica questa, è violenza di genere anche questa. È un sistema che usa il femminismo come marketing, mentre nella filiera reale la parola “diritti” è ancora considerata un lusso. E non riguarda solo le fabbriche lontane, nel cuore dell’industria nostrana le forme di violenza sono anche psicologiche, sottili, silenziose. Pressioni estetiche, ricatti contrattuali, molestie. Il 68% delle modelle ha subito pressioni dirette sul peso e il 28% molestie sessuali in contesto professionale.
E qui si apre la parte che abbiamo sempre voluto evitare, la salute mentale.
La moda romanticizza il crollo. Il genio incompreso. Il corpo “in forma” a qualunque costo. Ma i dati raccontano altro, più del 60% delle modelle dichiara di avere disturbi alimentari, quasi tutte riferiscono ansia, depressione da prestazione, isolamento. Il ciclo delle fashion week, le taglie campione, l’algoritmo che misura la visibilità come valore umano, tutto contribuisce a creare una violenza che non si vede, ma si interiorizza. Alexander McQueen. L’Wren Scott. Kate Spade. Jeremy Ruehlemann. E centinaia di persone non famose, bruciate da un settore che ti chiede di brillare mentre ti toglie ossigeno a poco a poco. La moda così com’è è una gabbia dorata, scintilla fuori e logora dentro. È un amore tossico, quello che da fuori sembra perfetto, ma dentro installa un driver di autosabotaggio.
Liquidare tutto questo come semplice marketing sarebbe comodo e falso. La moda è un dispositivo culturale capillare, entra negli armadi si ma anche negli algoritmi, nei giornali, nelle scuole, nei posti di lavoro. Definisce ciò che è desiderabile. E ciò che è desiderabile diventa ciò che è accettabile, dando vita ad una violenza strutturale.
La soluzione a questo non è moralista né purificatrice, non esiste una moda buona fuori dal capitalismo. Il punto è un altro, chi controlla il racconto. Perché finché a decidere chi merita spazio saranno sempre gli stessi sguardi e gli stessi poteri, la rappresentazione cambierà la superficie ma non struttura. La violenza più resistente è quella che si traveste da normalità.
Gli stereotipi non sopravvivono perché imposti con la forza, ma perché diventano cultura, abitudine, senso comune. L’egemonia culturale funziona così, trasformando narrazioni parziali in verità universali. E la moda è uno dei suoi strumenti più efficaci.
Non basta aggiungere un corpo diverso nel frame se il frame resta lo stesso. Un corpo può essere ferito con un gesto. Ma può essere letteralmente cancellato con un racconto.
La rivoluzione non comincia quando il sistema concede un posto, ma inizia quando chi lo abita si prende il diritto di riscrivere la scena non solo per essere guardata ma per guardare.
Perché finché il racconto non cambia, la violenza continuerà a indossarci e continueremo a chiamarla moda.
Leggi Anche: Lucia Salemme e la violenza che non si nomina
Serena Parascandolo




