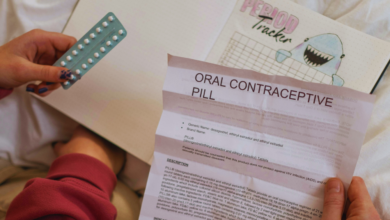Francesca Alinovi, una delle storie di femminicidio prima che esistesse

Francesca Alinovi, scritti per Arte di Frontiera, 1982
«Il margine è il luogo dove il futuro si forma. Prima del centro, prima della teoria, prima della storia.»
Il 12 giugno 1983, in una città che già allora amava definirsi laboratorio culturale, una donna veniva trovata riversa nel suo appartamento in via del Riccio. Il corpo, trafitto da quarantasette coltellate, era una ferita nuova in una Bologna che, fino a quel momento, si raccontava soprattutto attraverso gli anni di piombo.
Si chiamava Francesca Alinovi. Aveva 35 anni ed era una figura irregolare e luminosa, una mente che viveva un passo avanti — troppo avanti — rispetto al suo tempo.
Critica d’arte, docente, ricercatrice fuori schema, Francesca aveva intuito prima di molti che il centro dell’arte stava cambiando coordinate: non più solo musei, biennali e gallerie, ma muri, stazioni, periferie e comunità marginali.
Era tra le prime italiane a scrivere seriamente di graffitismo e di hip hop quando, nel resto del paese, il dibattito era ancora fermo a capire se il punk fosse arte o vandalismo.
Nel 1982 aveva curato Arte di frontiera. New York Graffiti, portando in Italia — per la prima volta — nomi come Kenny Scharf, Keith Haring, Rammellzee. Una mostra che oggi appare storica, ma che allora fu accolta con scetticismo. Francesca vedeva quello che gli altri non erano ancora pronti a vedere: l’arte come linguaggio politico, la strada come codice, il margine come luogo di produzione culturale. Nei suoi scritti non cercava la bellezza consolatoria: cercava la ferita. E provava a leggerne il senso. Aveva capito che sono i luoghi a parlare prima delle persone e che i margini sono sempre l’anticipo del futuro.
Come ha scritto la storica dell’arte Francesca Frisa, che le ha dedicato un numero speciale della rivista DUNE:
«Il problema non è solo ricordarla. Il problema è ricordarla bene. Non come un caso irrisolto, non come un mistero, ma come una presenza viva che parla ancora a ciò che siamo.»
Il suo assassino — Francesco Ciancabilla, 23 anni, allievo ed ex compagno sentimentale — fu condannato solo nel 1997, quattordici anni dopo. All’epoca dei fatti fu descritto come un giovane confuso, fragile, travolto da una relazione intensa. Ancora una volta, il movente era il sentimento, non il potere.
Il delitto fu brutale, ossessivo, eppure raccontato nei termini più antichi. I giornali titolarono la solita solfa: “storia di amore finita male, gelosia, passione deviata, tragedia privata”. Quasi un destino romantico degenerato. Nessuno parlava di violenza di genere, di femminicidio. Nessuno nominava la struttura, perché la struttura era ancora invisibile.
E qui arriva il punto: Francesca Alinovi non fu solo uccisa. Fu narrata male.
Non le fu attribuito un contesto, ma una colpa, quella di essere stata al centro di una storia d’amore malata. Il delitto fu spogliato della sua dimensione politica e relegato a fatto privato — e, inevitabilmente, fu lei a pagarne il prezzo anche dopo la morte.
Nel 1983 il femminicidio non era un concetto. Non esisteva nella legge, nei media, nel linguaggio comune. La violenza sulle donne veniva derubricata a conseguenza estrema di una relazione affettiva: se un uomo uccideva la compagna, “aveva perso la testa”.
La narrazione assolveva lui. E silenziava lei, ancora una volta.
E quando diciamo che nominare la violenza è un privilegio, intendiamo anche questo: la possibilità stessa di chiamare le cose con il loro nome è una conquista, non un punto di partenza. Perché ci sono stati decenni — e ce ne sono ancora — in cui il femminicidio veniva raccontato come gelosia, droga, devianza, fragilità maschile o squilibrio momentaneo.
Francesca Alinovi è diventata, per molti, una figura di culto. Ma è ancora troppo poco.
Il culto non è memoria. Il culto non protegge, non educa, non lascia eredità.
La memoria, invece, è politica davvero.
In questo caso, la memoria significa restituire un nome alla storia e restituire una storia al presente.
Quando parliamo di Francesca, non stiamo parlando del passato. Stiamo parlando di noi.
Stiamo parlando di tutte le volte in cui la violenza sulle donne viene ancora raccontata con le parole sbagliate: “raptus”, “gelosia”, “era un bravo ragazzo”, “una coppia in crisi”.
Stiamo parlando di tutte le volte in cui una morte viene spettacolarizzata invece che compresa.
Oggi abbiamo leggi, procedure, statistiche, centri antiviolenza. Abbiamo parole (spesso ridicolizzate, svuotate, strumentalizzate) come femminicidio, patriarcato, violenza di genere.
Abbiamo il 25 novembre, ma abbiamo anche un elenco di nomi che cresce, settimana dopo settimana.
Abbiamo ancora donne uccise da uomini che “sembravano tranquilli”, tribunali che minimizzano e media che romanticizzano.
Abbiamo ancora un Paese in cui la violenza viene letta come eccezione, mai come sistema.
E allora chiediamoci: se Francesca Alinovi fosse stata uccisa oggi, sarebbe cambiato qualcosa?
Sì: l’avremmo chiamato femminicidio. No: l’avremmo probabilmente raccontato allo stesso modo.
Ed è proprio questo che rende il concetto urgente.
Francesca Alinovi non è una storia del passato, è una responsabilità del presente.
È quello che succede quando la cultura non basta a salvarti, quando il talento non ti protegge, quando il progresso è una parola e non una pratica. Ricordarla oggi, nel mese dedicato alla lotta contro la violenza di genere, non significa commemorare una tragedia ma denunciare una continuità. Francesca non aveva diritto a quella parola, femminicidio.
E allora quella parola dobbiamo usarla noi non come memoria ma come mandato, perché la memoria non serve a piangere le morti, dovrebbe servire a impedirle.
Serena Parascandolo
Leggi Anche: Tutte le forme di violenza non fisica: dalla verbale alla psicologica fino a quella economica