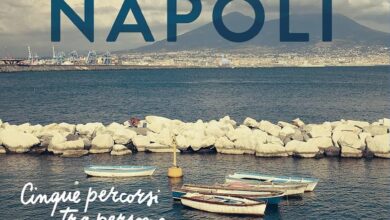Andrea Laszlo De Simone – Una lunghissima ombra
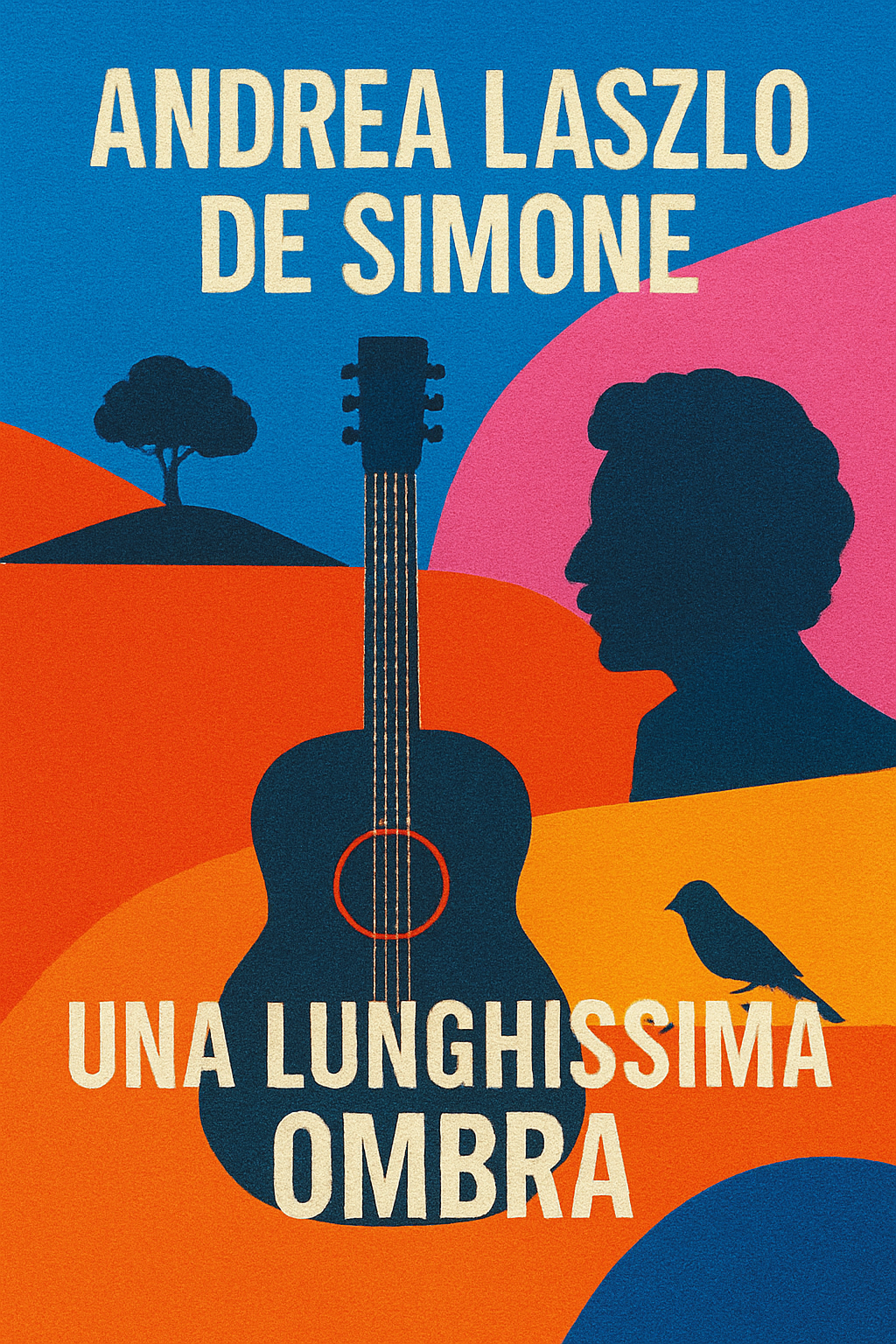
Una breve storia: Andrea Laszlo De Simone – classe ’86, torinese – resta uno dei grandi enigmi irrisolti della musica italiana. Schivo, diretto, allergico ai riflettori: niente televisione, niente social, e dal 2021 neanche più palchi. Pubblica solo quando per lui è inevitabile, come se la musica fosse un’urgenza che arriva da un altrove.
Vive a cavallo di due mondi: il cantautorato classico e un immaginario sonoro modernissimo, immerso in psichedelia, orchestrazioni da cinema e piccole derive sperimentali. Il secondo nome, ereditato in omaggio al direttore della fotografia ungherese László Kovács, tradisce la sua anima visiva — una lente poetica che filtra anche ogni sua nota.
Polistrumentista autodidatta, inizia come batterista nei Nadàr Solo, poi entra a far parte del duo Anthony Laszlo, fino a debuttare da solista nel 2012 con Ecce homo. Ma è con Uomo donna (2017) che conquista la critica, affermandosi come una delle voci più originali e visionarie della musica italiana degli ultimi vent’anni. Parallelamente, la sua sensibilità per le immagini lo porta a firmare colonne sonore per il cinema, tra cui il film francese Le Règne animal (The Animal Kingdom), che gli vale il Premio César 2024 per la miglior colonna sonora.
L’universo sonoro tra luci e ombre
Il mondo musicale di Laszlo somiglia a un paesaggio low-fi: registri caldi, fruscii, pianoforti sfuocati, synth che sembrano riflessi sull’acqua, archi che arrivano come fossero nebbia. Tra cantautorato minimale, derive psichedeliche, musica orchestrale e appunti rubati al reale, costruisce ambienti che oscillano tra oscurità morbide e lampi improvvisi.
Le sue influenze spaziano dalla tradizione cantautorale italiana — con rimandi battistiani e battiatiani — fino alla canzone d’autore francese e alla sperimentazione sonora contemporanea. I temi attraversano l’uomo nell’ombra della sua esistenza: amore, tempo che passa, rimpianto, memoria, desiderio e solitudine. Una lunghissima ombra (2025), il suo ultimo progetto, incarna questa tensione tra luce e ombra, memoria e attesa, segnando un nuovo capitolo della sua discografia, che comprende anche Ecce homo (2012), Uomo donna (2017) e Immensità (2019).
L’ultimo disco: Una lunghissima ombra
Pubblicato il 17 ottobre 2025, questo album non è semplicemente un disco: è un progetto audiovisivo, un «disco da vedere, un film da ascoltare». Le 17 tracce – alcune strumentali, molte con testi – percorrono territori già battuti dall’artista, ma li ampliano con nuove sfumature: elettronica, orchestrazioni classiche, interludi che paiono respiri tra le canzoni.
Non si tratta di una sequenza di singoli, ma di un vero viaggio: ogni brano è un tassello di un’esperienza fluida e immersiva, dove testi, musica e immagini si fondono. I temi centrali sono i pensieri intrusivi e le ombre che la nostra esistenza proietta sul mondo e su noi stessi. Ogni brano possiede una componente visiva: le inquadrature fisse della realtà rappresentano i punti di luce, i testi sono gli oggetti e la musica, al solito analogica e psichedelica, con reminiscenze folk e di canzoni d’autore francesi, è l’ombra. Un susseguirsi contemplativo e quasi psichedelico di epifanie, tra fuoco e nebbia, riflessioni che si fanno immagine e prendono vita.
Pellicola e musica: il video‑promo
Prima dell’uscita ufficiale del disco, Laszlo ha pubblicato un video di circa 67 minuti, privo della musica dell’album, composto da quadri filmici, rumori ambientali, frasi isolate e sottotitoli.
Il viaggio visivo inizia con una sigaretta appena accesa, il fumo che si disperde lentamente nello spazio, e si chiude con una foglia che ondeggia sospesa tra cielo e terra e un gruppo di uccelli che volteggia silenzioso sopra campi desolati, catturando una quiete sospesa tra reale e immaginario. Intermezzi come una stazione ferroviaria deserta, il crepitio di legna, un albero solitario in un campo o una vasca da bagno con una paperella galleggiante costruiscono un’architettura visiva e sonora che invita lo spettatore a immergersi nell’universo dell’album prima ancora di ascoltarlo.
Le frasi che compaiono sullo schermo anticipano i temi dell’album, offrendo veri “flash di ombra e luce”:
- «Forse ho mentito sempre o forse son troppo sincero / Ed ho una fragile mente, o sono solo immaturo…»
- «Cosa sappiamo di noi? / Cosa ci illumina / Cosa ci spinge / Cosa ci domina / Non è reale.»
- «Io mi accorgo di esser diventato grande / Vedo solo facce stanche / E quando viene sera / Proietto una lunghissima ombra.»
Questi frammenti contribuiscono a creare un clima sospeso, ipnotico e realistico, dove immagine e parola anticipano l’esperienza musicale vera e propria, facendo del video un’opera a sé stante. In seguito, la pellicola è stata proiettata nella cupola geodetica all’Angelo Mai di Roma nel giorno della release, e a quella sono seguiti i sold out delle proiezioni al Cinema Barberini, con nuove date annunciate in Italia e in Europa: Bologna (22/11), Berlino (28/11), Roma (7/12) e Torino (19/12).
Voce e stile: tra passato e innovazione
Dietro al look alla Frank Zappa, con baffo e capelli in stile anni Settanta, Andrea Laszlo De Simone possiede la voce e il respiro melodico di Lucio Battisti, capace di piegarsi alle emozioni con naturalezza, e insieme la fragilità espressiva di Claudio Rocchi, quella che trasforma ogni parola in un piccolo moto d’anima.
Per chi conosce a fondo la storia della canzone d’autore italiana, è impossibile non sentire un’eco di Enzo Carella — in quella sensualità discreta, negli arrangiamenti sinuosi, nell’eleganza mai ostentata che trapela anche fuori dal palco. E poi c’è l’ombra luminosa di Franco Battiato, nei frammenti mistici e nel modo in cui il pop si apre a una dimensione più ampia, quasi cosmica. Non si tratta di citazioni, ma di risonanze: Laszlo prende dai maestri la libertà e la profondità, trasformandole in un linguaggio personale, moderno, profondamente suo. È come se raccogliesse l’eredità dei maestri per poi ricrearla in una forma che gli appartiene interamente: un percorso autonomo, coerente e immediatamente riconoscibile, capace di sorprendere chi lo ascolta.
Perché ascoltarlo?
Vale la pena ascoltare Una lunghissima ombra perché Andrea Laszlo De Simone riesce a trasformare la musica in un dispositivo totale, dove suono e immagine non si limitano a coesistere, ma dialogano tra loro, creando uno spazio immersivo che cattura l’attenzione dall’inizio alla fine. L’album è anche un’esperienza di sperimentazione sonora: battiti che si insinuano tra orchestrazioni classiche, synth anni ’70 che evocano mondi lontani e campi d’aria che lasciano respirare la voce, componendo un universo sonoro unico e sorprendente. I testi, poi, non si limitano a evocare immagini o citazioni vuote: sono sguardi profondi sulle ombre della vita, sulle pause, sui silenzi e su ciò che resta tra luce e buio. E infine, il disco conferma una coerenza di percorso: dalle prime intuizioni di Ecce homo a Uomo donna e Immensità, Laszlo costruisce un percorso in continua evoluzione, sempre riconoscibile ma mai scontato, che lo conferma tra gli autori più interessanti della scena italiana contemporanea.
In conclusione
Nell’ateismo gentile di Laszlo, al posto di Dio c’è l’amore — una forza che attraversa tutto l’album come un respiro sotterraneo, riaffiorando più volte fino a esplodere nella dichiarazione pura e struggente di Per te. Non esiste un culto, ma un sentire: Laszlo non prega, ascolta. Non predica, ma si immerge nel mistero dell’essere umano, trasformando in suono ciò che ci accomuna, ciò che ci rende vivi e imperfetti.
Nelle interviste si definisce spesso una “cavia”, lo fa con un’ironia disarmata, per dire che i suoi pensieri non appartengono solo a lui, ma potrebbero essere di chiunque. È un artista che si espone in prima persona per restituire un’esperienza collettiva: un laboratorio emotivo aperto, dove l’intimità diventa universale.
E forse è proprio qui che risiede la forza spirituale del suo lavoro: nella poetica dell’umiltà, nella capacità di stare sul confine tra la carne e l’assoluto, senza mai fingere di aver trovato risposte. In un tempo saturo di parole urlate e polarizzazioni violente, la sua arte lieve e vaga — nel senso leopardiano del termine — diventa un gesto di resistenza e di cura, una forma di spiritualità laica che non promette salvezza, ma invita semplicemente a sentire.
Roberta Aurelio
Leggi Anche : James Senese, tra jazz e Mediterraneo: un ponte senza fine