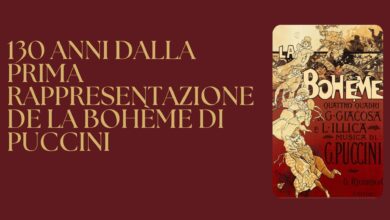Lo stile Rococò: un focus

Introduzione
Il termine Rococò si riferisce a uno stile sviluppatosi in Francia nella prima metà del Settecento, che si diffuse rapidamente in gran parte dell’Europa.
Il XVIII secolo europeo rappresenta una parentesi storica particolarmente significativa: iniziò col trionfo della monarchia assoluta di Re Luigi XIV e si chiuse con la Rivoluzione e con l’irrompere della modernità incarnata da Napoleone Bonaparte.
Definire il Rococò un semplice stile artistico sarebbe però riduttivo: esso rappresenta, al più, un periodo storico e culturale complesso, strettamente intrecciato con le svolte illuministe dell’epoca.
L’Illuminismo pose come fondamento primo la ragione, intesa nella sua forma più perfetta come scienza. Politica, vita sociale, arte, economia: tutto venne riconsiderato da una prospettiva “scientifica”.
In questo scenario l’arte aveva di fronte a sé tre possibilità:
- Differenziarsi dalla scienza, mantenendo una propria autonomia;
- Adeguarsi alla nuova mentalità razionale e critica;
- Rifondarsi come scienza autonoma, come scienza del bello ed estetica.
Queste tre possibilità possono essere, in maniera approssimativa, associate a tre stadi storici: l’estremo sviluppo del Barocco, l’elegante fioritura del Rococò e l’affermazione del Neoclassicismo.
Caratteristica dell’intero Settecento è il continuo processo di critica interna ai modi e ai fini dell’arte, una revisione del sistema instaurato dal Barocco. In tutta Europa questa critica si sviluppa in forme diverse: in Francia con gli scritti di Félibien e soprattutto di Diderot; in Inghilterra con Richardson e Webb, ma anche con Hogarth e Reynolds; in Germania con Winckelmann e Lessing.
In Italia, il movimento ha una posizione rilevante ma non centrale: le nuove idee trovano maggiori resistenze sociali e si intrecciano con tradizioni radicate. Ha quindi poco senso tracciare una separazione netta tra Rococò e Neoclassicismo, perché in Italia il razionalismo neoclassico nasce dentro il Rococò, sviluppandosi in forma di critica che lo corrode dall’interno.
Trasformazioni sociali: dal Barocco al Rococò.
Lo sviluppo del Rococò non può essere compreso senza considerare i profondi cambiamenti sociali e culturali che attraversano la Francia e l’Europa all’inizio del XVIII secolo.
Il Barocco era stato l’arte della grande celebrazione, della spettacolarità e del potere assoluto delle corti; con il nuovo secolo, però, la società aristocratica tende a ridefinire i propri spazi e i propri rituali: alle cerimonie solenni e collettive si sostituiscono momenti più intimi e mondani, come i ricevimenti nei salotti o le raffinate fêtes champêtres (feste campestri).
La vita di corte si sposta progressivamente dal fasto ufficiale alle atmosfere più private e leggere degli hôtels particuliers parigini, mentre le dimore aristocratiche diventano laboratori di eleganza e convivialità. Parallelamente, l’aristocrazia abbandona progressivamente le residenze rurali per trasferirsi nei centri cittadini, dove si impone un nuovo modello di vita sociale. Anche la borghesia urbana inizia a conquistare un ruolo sempre più significativo nell’economia e nella cultura e pur non condividendo gli eccessi e la frivolezza aristocratica, contribuisce a diffondere il gusto per il lusso e il piacere estetico, promuovendo arti decorative, collezionismo e produzione editoriale.
Il Rococò assume dunque declinazioni differenti a seconda dei contesti:
- In Francia, è soprattutto stile di corte e degli interni aristocratici, fatto di arredi preziosi, decorazioni leggere e pittura galante;
- In Germania e Austria, si lega a una forte componente religiosa, trovando nelle chiese e nei conventi riccamente decorati una delle sue massime espressioni;
- In Italia, si intreccia con le tradizioni locali e con le scuole pittoriche precedenti, raggiungendo il suo apice nella Venezia cosmopolita del Settecento, dove Tiepolo, Canaletto e Guardi aprono lo stile a un respiro europeo.
Il Rococò, nato come stile del piacere, della grazia e della leggerezza, non è solo un capitolo intermedio tra Barocco e Neoclassicismo, ma rappresenta un momento di trasformazione culturale e sociale, in cui l’arte riflette un mondo che si sta preparando, senza ancora saperlo, al cambiamento rivoluzionario di fine secolo.
Il Rococò in Europa: una panoramica
Il Rococò, pur nato in Francia, non rimase confinato a Parigi e a Versailles. Grazie alla circolazione di artisti, aristocratici e intellettuali, lo stile si diffuse in tutta Europa, assumendo connotazioni locali differenti.
Nato negli ambienti aristocratici parigini, trova spazio negli interni sontuosi degli hôtels particuliers, nei salotti e nelle residenze private. Qui trionfano la pittura galante (Watteau, Boucher, Fragonard) e le arti decorative (boiseries, specchi, porcellane, arredi leggeri). La Francia diventa anche il centro di elaborazione teorica e di gusto per tutta Europa.
In area tedesca e asburgica il Rococò si lega soprattutto all’architettura religiosa: conventi e chiese si riempiono di decorazioni luminose, stucchi bianchi e dorati, giochi prospettici e teatrali. Capolavori sono la Wieskirche in Baviera, la residenza di Würzburg, e i conventi di Ottobeuren e Melk. Qui lo stile si fonde con una tradizione barocca ancora molto viva, creando un effetto spettacolare e mistico.
In Italia questo stile si intreccia con tradizioni locali, senza una frattura netta con il Barocco. Venezia diventa il centro più importante, con la pittura di Tiepolo, Canaletto e Guardi, che porteranno lo stile oltre i confini nazionali. Sul piano architettonico, emergono capolavori come la Reggia di Caserta di Luigi Vanvitelli e la Palazzina di Caccia di Stupinigi di Juvarra, esempi di residenze teatrali e scenografiche.
In Spagna assume una declinazione decorativa soprattutto negli interni dei palazzi reali e nelle arti applicate (stucchi, altari, argenterie). Non si afferma come stile dominante in pittura, poiché la tradizione barocca rimane più radicata. l’Inghilterra accoglie il Rococò in forma più sobria, soprattutto nelle arti decorative e nell’architettura degli interni. Qui il gusto rococò si innesta sul modello palladiano dominante, senza stravolgerlo. In pittura, si afferma invece un filone più moraleggiante, distante dalle frivolezze francesi, con artisti come Hogarth, che criticano proprio I costumi aristocratici del tempo.
Anche in Russia e in Polonia lo stile penetra attraverso la committenza aristocratica e religiosa, dando vita a chiese e palazzi che fondono elementi locali e influssi occidentali.
Le caratteristiche artistiche del Rococò
La pittura rococò mantenne alcuni motivi barocchi (linee curve, decorazioni serpentine), ma li alleggerì con colori chiari e pastello (rosa, azzurri, verdi delicati). La grande novità fu la nascita della pittura degli attimi fuggenti: non più momenti solenni e drammatici, ma istanti di vita aristocratica, emozioni effimere, scene di piacere e mondanità. Temi frequenti: feste galanti, balli, spettacoli, pranzi all’aperto, scene di corteggiamento.
Tra I protagonisti principali ricordiamo: Jean-Antoine Watteau, inventore delle fêtes galantes; François Boucher, con scene mitologiche sensuali e pastorali raffinate; Jean-Honoré Fragonard, maestro di giochi amorosi e atmosfere giocose.
A questo si lega la categoria del pittoresco: paesaggi naturali irregolari e spontanei, spesso con rovine antiche, che diventano lo scenario ideale per la vita aristocratica. Parallelamente si sviluppò il vedutismo, legato al fenomeno del Grand Tour: nobili e intellettuali europei viaggiavano in Italia e acquistavano vedute delle città come ricordo.
I grandi maestri furono: Canaletto, per le vedute limpide e prospetticamente perfette di Venezia; Francesco Guardi e Bernardo Bellotto, che con stili diversi rielaborarono il genere; Giovanni Paolo Panini, attivo a Roma, celebre per le rovine monumentali; pittori stranieri come Philipp Hackert e Gaspar Van Wittel (padre di Luigi Vanvitelli). In architettura il Rococò si distingue per il contrasto tra semplicità esterna e sfarzo decorativo interno, con stucchi dorati, specchi, motivi vegetali, giochi di luce e ambienti teatrali.
Esempi:
- La Reggia di Versailles, trionfo del Barocco ma con interni che anticipano I fasti Rococò;
- La Reggia di Caserta (1752), progettata da Luigi Vanvitelli, grandiosa sintesi di razionalità e spettacolarità;
- La Palazzina di Caccia di Stupinigi (1729), capolavoro di Filippo Juvarra, raffinata residenza di svago della corte sabauda;
- Numerose chiese bavaresi e austriache (es. Wieskirche), caratterizzate da luminosità e decorazioni delicate.
Il Rococò in Italia
In Italia il Rococò portò un notevole rinnovamento soprattutto nella decorazione d’interni e nella pittura, con sviluppi più significativi nelle regioni settentrionali. Nell’Italia centrale, invece, a causa anche del forte peso della Chiesa, lo stile non trovò terreno fertile e non si affermò con caratteri particolarmente distintivi.
Un caso a parte è rappresentato dalla Sicilia, dove il Rococò si innestò su un’evoluzione locale del barocco di gusto spagnoleggiante, con influssi che ricordano il plateresco (stile decorativo sviluppatosi in Spagna tra XV e XVI secolo). Ne risultò una fusione originale, caratterizzata da ricchezza ornamentale e vitalità formale.
I principali protagonisti dell’architettura rococò in Italia furono: Filippo Juvarra, architetto di casa Savoia, autore di opere grandiose e scenografiche come la Palazzina di Caccia di Stupinigi; Luigi Vanvitelli, attivo presso I Borbone di Napoli, che realizzò la Reggia di Caserta, uno dei massimi simboli dello splendore settecentesco europeo. In pittura, i maggiori interpreti furono gli artisti veneziani: Giambattista Tiepolo, maestro degli affreschi monumentali e luminosi, che portò il Rococò a un respiro internazionale; Canaletto, celebre per le vedute limpide e prospetticamente rigorose di Venezia, molto richieste dai viaggiatori del Grand Tour; Francesco Guardi, che sviluppò uno stile più pittorico e vibrante, anticipando sensibilità moderne.
Nella scuola napoletana si distinsero invece: Francesco De Mura, raffinato interprete di soggetti religiosi e mitologici; Corrado Giaquinto, che coniugò eleganza rococò e intensità cromatica in numerose opere sia in Italia che in Spagna.
Per la Chiesa cattolica, tuttavia, lo stile Rococò appariva problematico: veniva percepito come un’arte troppo frivola ed esteriorizzata, simile alla musica profana, inadatta a favorire la preghiera e il raccoglimento. La sua leggerezza, la grazia e la mollezza dei motivi decorativi erano considerate poco conformi alla solennità della “casa di Dio. Il Rococò fu un’arte laica, aristocratica e mondana, che rifletteva il nuovo stile di vita delle élites europee, ma al tempo stesso si apriva a un pubblico più ampio attraverso il vedutismo e le arti decorative. Fu il tempo della grazia e della leggerezza, un ponte tra la spettacolarità barocca e la razionalità neoclassica, nonché il primo periodo in cui l’arte si emancipò davvero dal controllo religioso, aprendosi a una dimensione più privata e sensibile.
Roberto Spanò
Leggi Anche : Gli artisti di corte di Ferdinando IV