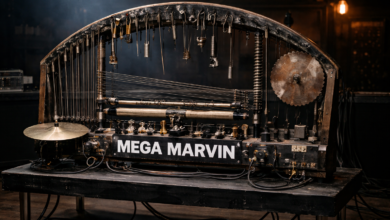Belve Crime: raccontare il crimine o offrire un microfono?

Belve Crime è partito con il botto. Un grande botto.
La prima puntata, con Massimo Bossetti, ha riaperto un tema delicato: la televisione deve solo intrattenere o farsi carico — almeno a volte — di rappresentare realtà scomode?
Può raccontare il male senza trasformarlo in intrattenimento? E soprattutto: quanto spazio meritano in TV i colpevoli?
Il programma condotto da Francesca Fagnani, noto per i suoi faccia a faccia pungenti, ha inaugurato il suo spin-off “crime” con un’intervista che ha diviso pubblico, critica e coscienze.
Belve Crime, luci puntate sul colpevole
Bossetti è stato sotto luci puntate mentre racconta la sua versione dei fatti, rivendicando incolpevolezza, ha lanciato accuse e si è anche commosso. Il tutto in un format esteticamente elegante, curato, persino drammatico. Ma a che costo?
La domanda è legittima: è davvero interesse del pubblico ascoltare la voce di chi è stato condannato per l’omicidio di una tredicenne? E quanto dista l’informazione dallo spettacolo?
Lo storytelling del male
Che il true crime abbia un’attrazione cupa è ormai un dato di fatto. E Belve Crime lo conosce bene. Non è sbagliato raccontare un caso giudiziario o scandagliare i lati oscuri della psiche umana. Ma è bene fare attenzione alla differenza sostanziale tra il racconto e l’offerta di un palcoscenico.
Anche se calibrata e ben condotta, l’intervista ha avuto l’effetto di rilanciare la figura di Bossetti come perno narrativo. Il suo viso, il suo racconto, le sue emozioni. A tratti sembrava che la vittima scomparisse dal quadro. Una presenza invisibile, sullo sfondo. Ecco appunto il rischio: trasformare chi ha commesso un delitto in protagonista narrativo, mentre le vittime scivolano via nel silenzio.
Il dolore ignorato
I genitori di Yara Gambirasio hanno dichiarato che vedere lì Bossetti è stato un colpo basso. Un’ennesima ferita. Ancora più dura da digerire quando viene somministrata in prima serata, sulla TV pubblica, con una regia attenta e uno share da record.
Qual è il senso di tutto questo? È legittimo pensare che una parte del successo del format dipenda non dal contenuto, ma dalla morbosità del contenitore. L’idea stessa che un condannato per omicidio possa diventare un “caso mediatico” da prime time è il segnale che qualcosa, nel nostro modo di fare informazione, si è rotto.
Belve Crime, il merito della Fagnani (e i suoi limiti)
Francesca Fagnani è una giornalista che conosciamo già per la sua serietà, per le sue abilità, e la sua giusta freddezza. Le sue domande mettono a disagio, e in alcuni momenti ha messo Bossetti con le spalle al muro. Ma la struttura del programma — le luci, la musica, il montaggio — sembrava voler umanizzare chi, per sentenza, ha compiuto qualcosa di disumano.
C’è un corto circuito evidente tra la tensione morale del format e la sua estetica accattivante. L’informazione si veste da thriller, e il limite tra analisi e fiction si spezza.
Una responsabilità editoriale
Il problema non è Belve Crime in sé. Il problema è un certo modo di usare il crimine come leva narrativa. Non è un male raccontare la criminalità. Ma bisogna stare attenti al come. La regia dev’essere etica prima che televisiva. Occorre chiedersi non solo “possiamo farlo?” ma “ha senso farlo così?”
Il dolore non è una trama. Le vittime non sono quinte sceniche. I colpevoli non sono star.
Conclusione: chi raccontiamo davvero?
In casi così delicati, come quello di Bossetti, la scelta del punto di vista non è mai neutra: inevitabilmente condiziona il racconto, ma soprattutto la percezione del pubblico. Se il protagonista è il carnefice, se la voce dominante è la sua, se l’emozione più forte è la sua sofferenza, allora qualcosa non va. Perché il pubblico, anche quello più attento, viene inevitabilmente trascinato là dove lo sguardo si sofferma più a lungo.
E quando lo sguardo si ferma sul volto dell’assassino — mentre la vittima resta un nome pronunciato a metà — è lì che la narrazione perde senso.
Arianna D’Angelo
Leggi anche: Teo Mammucari a Belve: tensioni e fragilità rivelate
Photocredits: www.rai.it