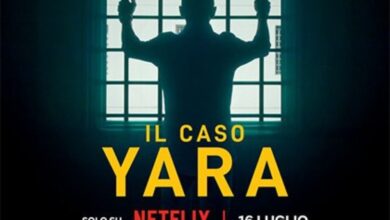Nulla di più bianco della blackface

Poche settimane fa il rapper Ghali, di origini tunisine, comunicava con chiarezza tutto il suo disappunto nei confronti di un programma Rai di grande successo, Tale e quale show.
Al centro della polemica è la discutibile maniera in cui il programma cerca di “omaggiare” artisti neri, riproducendone tratti somatici, colori e timbriche.
Ed ecco che in un attimo, in un 2020 che non sa cosa altro fare per farsi odiare, rispunta una pratica che sembrava ormai superata: la blackface.
Per intenderci immediatamente, la blackface è la riproduzione, in chiave caricaturale, dei tratti tipicamente afro. Nella blackface i tratti somatici, i colori, l’abbigliamento, la dizione imperfetta di chi spesso è alloglotta, vengono volutamente marcati in modo da creare una caricatura che risulti allo stesso tempo immediatamente riconoscibile e risibile.
Questa pratica nasce intorno agli anni ’30 del XIX secolo, con i Minstrel show: brevi intermezzi o talvolta interi spettacoli comici in cui uomini afroamericani vengono rappresentati, da attori bianchi pesantemente truccati, in modo stereotipato e offensivo. Siamo nell’America del XIX secolo, che ancora sguazza nel più brutale razzismo e in cui questi spettacoli non fanno altro che alimentare diffidenze e discriminazioni razziali.
Questa forma di intrattenimento, dopo aver raggiunto anche l’Europa attraverso la Gran Bretagna, verrà gradualmente abbandonata con il sopraggiungere della lotta alle discriminazioni e alla segregazione razziale sostenuta da Martin Luther King, fino a scomparire intorno agli anni ’50 del XX secolo.
Nei Minstrel show attori bianchi riproducevano i tratti tipicamente neri in modo goffo e caricaturale: la faccia veniva dipinta di nero con sughero bruciato, cerone o lucido da scarpe, le dimensioni della bocca venivano esasperate, la tipica capigliatura afro veniva riprodotta con parrucche di lana. Della comunità afro, già brutalmente fruttata e discriminata, veniva messa alla berlina la condizione economica, il ruolo sociale, le caratteristiche e i valori morali: gli afroamericani, dati in pasto ad un pubblico bianco, venivano rappresentati come pigri, indolenti, superstiziosi, straccioni, con una smodata passione per la musica.
L’onta della blackface colpisce addirittura le compagnie afroamericane che si esibiscono nei Minstrel show raggiungendo il massimo dell’umiliazione razziale. L’esibizione caricaturale della negritudine ottiene successo e le compagnie teatrali afroamericane non possono non tenerne conto: attori neri, allora, accentuano i propri tratti, coprono la pelle nera con strati di cerone, storpiano la propria dizione, si ridicolizzano su un palcoscenico.
È innegabile che il teatro statunitense dell’Ottocento, giocando su una comicità scorretta e bassa, abbia avuto un ruolo di fondamentale importanza nel radicarsi di atteggiamenti razzisti e discriminatori, atteggiamenti che la società statunitense farà un’immensa fatica a stigmatizzare e che tutt’oggi non sono del tutto estirpati.
Questa pratica, agli inizi del ‘900, si diffonde anche nel cinema: nella prima versione cinematografica conosciuta de La capanna dello zio Tom (1903) tutti i ruoli principali di neri vengono interpretati da bianchi in blackface.
In Italia, in un passato non troppo remoto, nomi celebri della tradizione cinematografica inciampano nella blackface. Basta pensare a Totò in Tototruffa ’62, mascherato da ambasciatore di un paese fittizio, il Catonga, con il volto dipinto di nero e un anello al naso, che imita l’incerta dizione dei neri che parlano italiano, oppure Ugo Tognazzi e Gianni Agus in Angeli Negri (1958) che ripropongono un’immagine dei neri selvaggia e goffa.
Eppure, questa pratica, che è molto più di un banale make-up teatrale, ha lasciato strascichi chilometrici che arrivano ai giorni nostri e che trasformando, ancora oggi, un’innocente omaggio ad un artista in un clamoroso scivolone razzista, un gesto simbolico di solidarietà antirazzista in una gravissima offesa.
È il 2018. Accendi la tv e Gino Sorbillo, noto pizzaiolo napoletano, protesta contro gli insulti razzisti rivolti al calciatore del Napoli Koulibaly durante il match Inter-Napoli, truccandosi il volto di nero.
È il 2020. Il movimento antirazzista Black Lives Matter denuncia l’ennesimo omicidio razziale in America, quello di George Floyd, ucciso per soffocamento da un poliziotto: sei su Instagram e numerose star, che danno il loro contributo al movimento, si ritraggono con il volto truccato di nero.
Sei sul divano assieme alla tua famiglia: Tale e quale show, programma di punta della Rai, propone imitazioni di artisti, viventi e non, facendo ricorso alla blackface.
Sfogli un sussidiario: un bambino nero, dall’italiano incerto (perché come può mai essere l’italiano di un bambino nero nato in Italia?), ci informa in modo goffo e sgrammaticato di voler imparare la lingua del Bel Paese.
Un volto annerito a favor di camera, una lingua storpiata da un bambino nero, un bianco che diventa nero per una sera, per il tempo di un’esibizione, che lo fa per divertire, per intrattenere: che cos’è cambiato allora dai Minstrel show?
Nulla, assolutamente nulla, se non l’ignoranza, da parte di chi usa la blackface, del significato più profondo della blackface.
Perché, se non si vuole credere che le intenzioni alla base dell’attuale ricorso alla blackface nello spettacolo siano altre, l’unica spiegazione è l’ignoranza. L’ignorare cosa significhi, ancora oggi, essere nero h24, cosa abbia significato questa pratica per la comunità afroamericana, quanto sia costato, in termini di sforzi e di vite, buttare giù a suon di proteste e battaglie secoli di pregiudizi e discriminazioni.
È, dunque, giusto ancora oggi giustificare, con l’attenuante delle buone intenzioni, con la scusa dell’ignoranza, con la motivazione della solidarietà, con il fine del divertimento, il ricorso ad una pratica che non ha alcuna utilità, che crea imbarazzo e disagio, che lava via come una spugna secoli di schiavitù, di lotte e sofferenze?
La risposta non va a lungo ponderata: no!
Valentina Siano
Vedi anche: Martin Luther King e il sogno americano